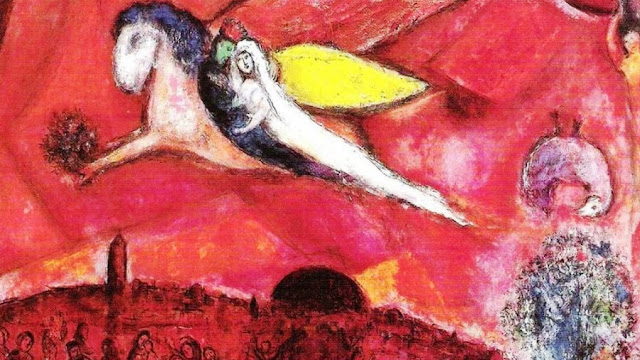Il VIII 'Salottino'
del 19 e del 26 febbraio 2019
“Il giorno seguente non morì nessuno.”
Cosa succederebbe se di colpo le leggi
naturali cambiassero e proprio lì sull’orlo dell’aldilà nessuno facesse più il
passo decisivo? Sarebbe un sogno, la terra promessa, una manna. Vita eterna ai
felici mortali, liberi finalmente da quella scomoda punizione per il peccato
originale.
Le Intermittenze della Morte di José
Saramago è un assurdo viaggio sul filo tra luce e ombra. Un macabro teatrino
che mette in scena l’eventualità di una vacanza della morte: contrariamente a
quanto si pensi però, il cambiamento non porterebbe nulla di buono. L’uomo non
è pronto per un simile cambiamento e riuscirebbe anche nella nuova situazione
di immortalità a dare prova di bassezze tipiche di lui, perchè in fondo “resta
pur sempre un uomo”.
Insomma, se da un giorno determinato in
poi in un intero paese non morisse proprio nessuno forse sarebbe istituita
festa nazionale, ma ci sarebbe poco da festeggiare quando i moribondi sul filo
della vita inizierebbero ad accatastarsi negli ospedali e nelle case, cocciuti
comatosi che non vogliono saperne di darci un taglio, inutili fantocci sul
bordo del baratro.
La società risentirebbe di un simile
cambio di programma, non sapendo gestire la novità e mancando di qualunque tipo
di self control britannico: cosa farebbero le agenzie di pompe funebri, le
assicurazioni, le pensioni, cosa i politici e i politicanti, cosa la chiesa
cattolica? Entrerebbero in gioco dinamiche contraddittorie, valori disumani,
persino e non sorprendentemente un’organizzazione maphiosa (con la ph).
Quand’ancora la morte decidesse di porre
fine alle sue ferie non pagate e tornasse a manifestarsi creando un’ecatombe
nel giro di un secondo, cosa succederebbe – propone ancora Saramago – se si
scoprisse amante del progresso e desse una svolta al vecchio sistema? Niente
più stacchi improvvisi di corrente, bensì lettere viola recapitate per posta
con otto giorni di anticipo al disgraziato interessato: “Il suo tempo scade tra
poco più di una settimana, si prepari alla departita”. Che follia, che
disperazione sarebbe per i poveri uomini, conoscere in anticipo la data della
loro fine! Come prodotti da frigo, come mucche da macello. Cercherebbero di
sfuggirle o si offrirebbero in stoici autodafè. Ma la morte non risparmierebbe
nessuno.
Forte di un gioco dell’assurdo, Saramago
conduce una ginnastica mentale intorno a ciò che significa la morte nella
nostra società, cercando di dare un volto, una voce, un pensiero persino alla
morte stessa. E’ un ritratto insolito ed ambivalente di una temibile ed
imperiosa funzionaria che si fà da mietitrice a postina, fino allo scontro con
la fatidica eccezione: un uomo, un qualunque violoncellista, che si ostina a
non morire. Le lettere viola inviategli fanno irrimediabilmente ritorno al
mittente. E’ necessario che la morte “in persona”, “in carne ed ossa” –
qualunque espressione sarebbe un eufemismo – gli faccia visita per svolgere
l’ingrato compito. Ma ad andargli incontro sarà una morte femmina, donna, pure
carina.
Speculazioni sulla morte sottili e
delicate, paradossali nel loro cinismo ed inquietanti nella loro linearità.
Pagina dopo pagina, nello stile concitato che gli è proprio, l’autore infila
come perle frasi divise a malapena da punti, spesso senza punteggiatura e
volutamente senza la maiuscola. “Realmente non c’è nulla di più nudo di uno
scheletro” scrive Saramago, eppure la sua morte sembra di poterla toccare, una
parca divenuta protagonista di una storia non solo umana, il che è la
normalità, ma di donna.
Nella densa vicenda di questa
morte che viene e che va si scorge talvolta anche la parola “vita”: risalta
bianca sul nero, lascia riecheggiare la sua presenza cristallina, ogni sua
comparsa è una bolla di stupore. Una presenza, quella della vita, che diventa
sempre meno rada mano a mano che ci si avvicina alla fine del romanzo.
Perchè in un mondo in cui ogni giorno
catastrofi naturali, storiche e politiche portano via con sè una percentuale
della massa umana del nostro pianeta, forse l’autore ha sentito il bisogno di
darsi una spiegazione della parola “fine”, dell’altra faccia della medaglia. Ed
ha saputo provare che, nonostante tutto, la cosa migliore è che ci sia la
morte: che ci si vuol fare, così è la vita.
(da Chiara Piotto)
* * *
Il paradosso è il protagonista del romanzo Le intermittenze della morte
del Premio Nobel per la letteratura, José Saramago.
Il paradosso è rappresentato dalle conseguenze che derivano, in un
ipotetico Paese di dieci milioni di abitanti, dove la morte ha deciso di
sospendere la propria consueta attività. Il popolo è in festa e sui balconi
delle case vengono affisse le bandiere nazionali in segno di giubilo. Non
altrettanto liete sono le autorità civili e religiose, a giudicare dalla
telefonata che intercorre tra il primo ministro e un eminente cardinale:
“Buonasera, signor primo ministro, Buonasera,
eminenza, Le telefono per dirle che mi sento profondamente scioccato, Anch’io
eminenza, la situazione è molto grave, la più grave di quante il paese ha
dovuto vivere fino a oggi, Non si tratta di questo, Di che si tratta allora,
eminenza, È deplorevole sotto tutti gli aspetti che, nel redigere la
dichiarazione che ho appena ascoltato, lei, signor primo ministro, non si sia
ricordato di quello che costituisce il fondamento, la trave maestra, la pietra
angolare, la chiave di volta della nostra santa religione, Eminenza, mi perdoni,
temo di non comprendere dove vuole arrivare, Senza morte, mi ascolti bene,
signor primo ministro, senza morte non c’è resurrezione, e senza resurrezione
non c’è chiesa”
Quali le prospettive per il Paese? Si lamentano le imprese degli affari
funerari, le agenzie di pompe funebri, gli ospedali dove continuano ad entrare
gli infermi senza che ne escano i morti, le case di riposo per la terza e
quarta età, per il venir meno della “sicurezza derivante dalla continua e
inarrestabile rotazione di vite e morti”. E le compagnie di assicurazioni? Chi
vuole più stipulare una polizza sulla vita, dal momento che non si muore più?
Per non parlare dello Stato che, nel breve tempo, non sarà più in condizione di
far fronte al pagamento delle pensioni né alle crescenti spese sanitarie,
giacché la sospensione della morte non significa che gli infermi guariscano.
Inoltre, l’aumentato numero di malati terminali, ridotti ormai in condizione di
decrepitezza, pone il problema della continua assistenza pubblica e privata.
Le famiglie, che avevano salutato con entusiasmo l’avvento della nuova era, esente da morte, sono ora costrette a riflettere su un problema dal duplice aspetto: come assistere i propri infermi, vecchi decrepiti o malati terminali, e come porre fine alle loro, talora indicibili sofferenze, soprattutto quando sono essi stessi a chiedere di voler morire. E la soluzione, tra tentennamenti e rimorsi, viene subito individuata: altrove la morte continua a fare il proprio lavoro, basterà trasportare i moribondi, nottetempo e clandestinamente, fuori dei confini nazionali, la falce li colpirà all’istante e in quei luoghi avranno sepoltura.
Sorgono nuovi problemi: l’idea del “trasporto” si propaga velocemente tra
le famiglie, il governo è costretto a nominare sorveglianti ai confini del
territorio nazionale, per impedire ufficialmente i viaggi per andare a morire,
anche se in cuor suo vede nell’iniziativa un rimedio contro i propri mali. La
“soluzione” diffusasi spontaneamente tra le famiglie, diventa un affare per le
organizzazioni mafiose che ora monopolizzano il lucroso traffico. I
sorveglianti vengono spesso malmenati e lo Stato sarà costretto a patteggiare:
continuerà a mandare i sorveglianti, ma questi chiuderanno un occhio e talora
tutti e due, ma a questo punto si scatenerà l’opposizione politica contro il
governo.
Dopo poco più di sette mesi di irreperibilità, la morte torna a farsi viva con una lettera inviata al direttore generale della televisione nazionale, perché egli ne dia notizia in prima serata al pubblico dei telespettatori, subito dopo un comunicato del governo:
Dopo poco più di sette mesi di irreperibilità, la morte torna a farsi viva con una lettera inviata al direttore generale della televisione nazionale, perché egli ne dia notizia in prima serata al pubblico dei telespettatori, subito dopo un comunicato del governo:
“Nel preciso istante in cui l’annunciatore finì di
leggere il comunicato del governo, la telecamera numero due inquadrò il
direttore generale. Si notava che era nervoso, che aveva un groppo in gola.
Tossicchiò per schiarirsi la voce e cominciò a leggere,signor direttore
generale della televisione nazionale,stimatosignore, per gli effetti che gli
interessati riterranno convenienti sono qui per informare che a partire dalla
mezzanotte di oggi si tornerà a morire come succedeva,senza proteste
notorie,sin dal principio dei tempi e fino al giorno trentuno dicembre dello
scorso anno, devo spiegare che l’intenzione che mi ha portato a interrompere la
mia attività, a smettere di ammazzare, a rinfoderare l’emblematica falce che
fantasiosi pittori e incisori d’altri tempi mi hanno messo in mano, è stata di
offrire a quegli esseri umani che tanto mi detestano una piccola dimostrazione
di cosa sarebbe per loro vivere sempre, cioè eternamente […] dunque
rassegnatevi e morite senza discutere perché non vi servirebbe a
niente,tuttavia, c’è un punto su cui mi sento in obbligo di riconoscere il mio
errore,il quale punto ha a che vedere con l’ingiusto e crudele procedimento che
stavo seguendo, vale a dire togliere la vita alle persone a tradimento, senza
preavviso, senza un allerta […],insomma, d’ora in poi tutti quanti saranno
avvertiti e avranno la scadenza di una settimana per mettere in ordine quanto
ancora gli resta di vita, fare testamento e dire addio alla famiglia, chiedendo
perdono per il male fatto o facendo la pace con il cugino con cui avevano rotto
i rapporti da vent’anni[…]”
Il comunicato della morte, ancorché inusitato, lascia tutti sgomenti. Non
soltanto coloro che continuavano a gioire per la sua assenza e il suo silenzio,
ma tutti gli altri, per il problema di dover fronteggiare “ben più di
un’ecatombe” nel giro di tre ore, quando i moribondi, a decine e decine di
migliaia, moriranno tutti nello stesso istante. Più grave ancora, la nuova
consapevolezza circa le lettere viola che d’ora in avanti la morte farà
recapitare a coloro cui resta solo una settimana di vita.
Facile immaginare in quale stato sarebbe precipitato l’uomo che, godendo di buona salute, si fosse visto recapitare una di queste lettere viola:
Facile immaginare in quale stato sarebbe precipitato l’uomo che, godendo di buona salute, si fosse visto recapitare una di queste lettere viola:
“Caro signore, sono spiacente di comunicarle che la
sua vita terminerà alla scadenza improrogabile di una settimana, faccia del suo
meglio per godersi il tempo che le resta, la sua attenta servitrice, morte.”
Cosa avrebbe potuto fare quest’uomo? Piangere con i familiari per il tempo
che gli resta o trastullarsi per sette giorni in bagordi? O magari scrivere
alla morte chiedendo spiegazioni,
“sapendo comunque che non riceverà risposta, perché la
morte non risponde mai […]”
Il Servizio ufficiale di identificazione del Paese viene messo in allarme:
un famoso specialista nella ricostruzione di volti sulla base dei teschi e
delle tante raffigurazioni antiche della morte, giunge alla conclusione che la
morte è una donna. Alle stesse conclusioni era già pervenuto il grafologo,
studiando il comunicato che la morte aveva inviato al direttore generale della
televisione nazionale.
La scoperta avrà delle conseguenze, quando la morte si vedrà recapitare indietro la lettera viola inviata ad un musicista, la cui essenza o il cui ritratto, se lo si fosse potuto rappresentare in musica, sarebbe stato il breve studio di Chopin, Opera 25, numero 9 in sol bemolle maggiore. E qui inizia la parte più bella e intrigante di questo avvincente romanzo di Saramago.
La scoperta avrà delle conseguenze, quando la morte si vedrà recapitare indietro la lettera viola inviata ad un musicista, la cui essenza o il cui ritratto, se lo si fosse potuto rappresentare in musica, sarebbe stato il breve studio di Chopin, Opera 25, numero 9 in sol bemolle maggiore. E qui inizia la parte più bella e intrigante di questo avvincente romanzo di Saramago.
Può l’amore vincere il fato e la morte?
Si presenta qui
la sagace conoscenza che José Saramago ha del mito, della musica e della
psicanalisi. Per Freud, amore e morte, le pulsioni fondamentali
dell’essere umano, sono sempre connesse tra loro. Thanatos, morte, è
contenuta in Eros, ed Eros è anche una faccia di Thanatos, perché solo
l’amore è in grado di guidare l’anima nel regno della psiche, al di sotto
e al di là della semplice vita, nei territori impervi delle ombre,
il solo universo dove il “per sempre”
e l’eterno sono di casa.
* * *
José Saramago (Azinhaga, 16 novembre 1922 - Lanzarote
2010), scrittore,
poeta e critico letterario.
Nel 1947 scrive il suo primo romanzo "Terra del peccato". Durante gli
anni sessanta riscuote molto successo la sua attività di critico letterario
per la rivista "Seara Nova". La sua prima raccolta di poesie "I poemi possibili" risale a al
1966.
Dal 1974 in poi, in seguito alla cosiddetta
"Rivoluzione dei garofani" Saramago si dedica completamente alla
scrittura e getta le fondamenta di quello che può essere definito un nuovo
stile letterario ed una nuova generazione post-rivoluzionaria.
Saramago pubblica qualche anno dopo, nel 1977, il
romanzo "Manuale di pittura e
calligrafia", e, nel 1980, "Una
terra chiamata Alentejo". Il successo arriverà però con "Memoriale del convento" (1982).
Il
riconoscimento a livello internazionale arriverà però solo negli anni novanta,
con "Storia dell'assedio di Lisbona"
(1989), una delle più belle storie d'amore mai scritte, il controverso "Il Vangelo secondo Gesù" (1991) e
"Cecità" (1995), che molti
considerano il suo capolavoro e “Le
intermittenze della morte” (2005).
Nel 1998 gli viene assegnato il premio Nobel per la
letteratura, riconoscimento che suscita molte polemiche nel mondo cattolico per
le sue ben note posizioni antireligiose. Polemiche che lo fanno decidere di
trasferirsi a Lanzarote, nelle isole Canarie, dove muore nel giugno 2010.
____________________________________________________________
Il VII 'Salottino'
del 5 e del 12 febbraio2019
Luigi Pirandello è uno
degli scrittori più importanti della letteratura italiana ed europea. La
ragione di tanta considerazione è dovuta al modo in cui egli ha saputo rinnovare
le forme e i generi della letteratura. Dopo Pirandello il teatro,
il romanzo
e la novella
non saranno più quelli di prima: egli segna un punto dal quale non è possibile
tornare indietro. Pirandello scrive e mette in scena cose che mai prima
erano state scritte e messe in scena e per questo il suo successo fu
strepitoso, sia durante la sua vita che dopo la sua morte e, ancora oggi, è uno
degli autori più
letti e amati dal pubblico.
Esistono
alcuni momenti nella storia della letteratura che segnano una rivoluzione, un
cambiamento epocale. Uno di questi è la nascita del teatro pirandelliano, in cui troviamo una
carica sperimentale e innovativa che apre la strada a molto di quello che è
venuto dopo in campo teatrale e letterario, ma anche nel nostro modo di vedere
il mondo.
*
* *
Luigi Pirandello nasce il
28 giugno 1867 in Sicilia, vicino Girgenti (oggi Agrigento
,) precisamente in una località chiamata Caos. Su questo lo scrittore amò sempre scherzare,
definendosi “figlio del caos”.
La casa natale di Luigi
Pirandello
Quando (nel
1853) si decise che la borgata divenisse comune autonomo, «la linea di confine
fra i comuni di Girgenti e Porto Empedocle venne fissata all'altezza della foce
di un fiume essiccato che tagliava in due la contrada chiamata "u Càvuso" o "u Càusu" (pantalone) [...] Questo Càvuso apparteneva metà al nuovo comune
di Porto Empedocle e l'altra metà al Comune di Girgenti [...] A qualche
impiegato dell'ufficio anagrafe parve che non era cosa [che si scrivesse che
qualcuno fosse nato in un paio di pantaloni] e cangiò quel volgare "Càusu" in "Caos"».
L'infanzia
di Pirandello fu serena ma caratterizzata anche dalla difficoltà di comunicare
con gli adulti e in particolare con il padre. Il giovane Luigi era molto devoto alla Chiesa
cattolica grazie all'influenza che ebbe su lui una domestica di famiglia, che
lo avvicinò alle pratiche religiose, ma inculcandogli anche credenze
superstiziose fino a convincerlo della paurosa presenza degli spiriti. Si
allontanò dalle pratiche religiose per un avvenimento apparentemente di poco
conto: un prete aveva truccato un'estrazione a sorte per far vincere
un'immagine sacra al giovane Luigi; questi rimase così deluso dal comportamento
inaspettatamente scorretto del sacerdote che non volle più avere a che fare con
la Chiesa, praticando una religiosità del tutto diversa da quella ortodossa.
Appassionatosi
alla letteratura, iniziò i suoi studi universitari a Palermo; a Roma continuò i
suoi studi di filologia romanza, che poi completerà a Bonn, dove si laureò nel 1891 con una tesi
sul dialetto di Girgenti.
A Girgenti,
Pirandello sposò Maria Antonietta Portulano, figlia di un ricco socio del
padre. Questo matrimonio concordato soddisfaceva anche gli interessi economici
della famiglia di Pirandello. Grazie alla dote della moglie, la coppia godeva
di una situazione molto agiata, che permise ai due di trasferirsi a Roma. A Roma, entra negli ambienti letterari,
collabora con alcune riviste e pubblica le prime novelle e i primi
romanzi.
Nel
1903, un allagamento e una frana nella miniera di zolfo di Aragona di proprietà
del padre, ridusse sul lastrico la famiglia di Pirandello. Questo avvenimento provocò
il disagio mentale della moglie Antonietta. Ella era sempre più spesso soggetta
a crisi isteriche, causate anche da una gelosia paranoica. La chiamata alle
armi di Stefano nella Grande Guerra peggiorò ulteriormente il suo stato di
salute. Antonietta Portulano morirà in una clinica per malattie mentali di Roma, a 88 anni di età. La malattia della
moglie portò lo scrittore ad avvicinarsi alle nuove teorie sulla psicoanalisi
di Freud e allo studio dei meccanismi dei processi mentali.
Il suo primo successo letterario fu determinato dal romanzo “Il
fu Mattia Pascal” (1904),
subito tradotto in diverse lingue. Gli
altri romanzi di Pirandello
(“Uno nessuno e centomila”, “L’Esclusa”)
ottengono grande diffusione, ma sarà il suo teatro a proporlo
all’attenzione internazionale.
Dopo la calorosa accoglienza della sua commedia “Sei personaggi in cerca d’autore”
(Milano, 1921), Pirandello fondò la Compagnia del Teatro d'Arte di Roma. Nel giro di un decennio divenne il drammaturgo
di maggior fama nel mondo, tanto da ricevere il premio Nobel per la letteratura
nel 1934, "per il suo ardito e ingegnoso rinnovamento dell'arte drammatica e
teatrale".
Molte delle opere pirandelliane cominciavano intanto ad
essere utilizzate come soggetti cinematografici. E proprio mentre
assisteva a Cinecittà alla lavorazione di un film tratto dal suo romanzo Il
fu Mattia Pascal, si ammalò di polmonite. Morì a 69 anni, il 10 dicembre 1936.
Porto Empedocle - Il cippo di pietra con le
ceneri di Luigi Pirandello
Il Teatro pirandelliano
Il teatro
rappresenta la parte più interessante della produzione artistica di Pirandello.
L’autore diceva: “Se l’uomo è una
maschera e se la vita è la recita di una parte, cosa c’è di meglio del teatro
per rappresentare la vita stessa?”. Pirandello cominciò a dedicarsi alla
produzione teatrale su suggerimento dell’amico scrittore siciliano Nino
Martoglio. Scrisse 53 commedie, incluse in un’unica raccolta: “Maschere
Nude”.
Conformemente
alla sua poetica, che affida all’arte il compito di denudare la maschera,
Pirandello chiamò il suo teatro “Teatro
dello specchio”, poiché in esso viene rappresentata la vita nuda, con le
amarezze e le sofferenze che risiedono dietro il velo di ipocrisia che
trasforma i volti in maschere. In questo modo era come se lo spettatore vedesse
se stesso (il volto) tramite uno specchio (la maschera). L’artista è dunque
l’umorista che ha il compito di svelare le illusioni e togliere le maschere per
ridurre l’esistenza alla sua nudità. Per fare ciò, Pirandello si serve del
grottesco, cioè l’umorismo espresso nel teatro.
La maschera e il volto
Pirandello
ruppe la cosiddetta “quarta parete”:
superò il diaframma del palcoscenico e fece partire l’azione dalla platea,
mescolando così attori e pubblico. L’attore non doveva più impersonare la parte
mistificandola, ma doveva mostrarla conservando un certo distacco dal
personaggio. Egli creò così il teatro nel
teatro, facendo vedere come la vicenda si costruisce nella scena così come
si delinea nella mente del regista. Il teatro pirandelliano viene anche
definito metateatro, cioè un tipo di teatro che si serve di se stesso per
discutere dei propri problemi esistenziali.
I testi teatrali di Pirandello sono delle storie
paradossali, che riflettono una vita claustrofobica spesso risolta in gesti folli e
anticonvenzionali, che ribaltano la realtà e deridono l’eccessiva serietà del
mondo. Se il mondo è una gabbia, il
teatro deve mostrare il momento di ribellione e di disordine
che, anche all’interno di una prigione, può cambiare il senso delle cose. Con
il suo teatro
Pirandello distrugge
dunque le convenzioni, elimina la barriera tra realtà e
finzione, tra autore e personaggio, tra pubblico e attore.
Tre
'concetti-chiave'
Il conflitto tra vita e forma
Per Pirandello
la realtà è un continuo conflitto
tra vita e forma. La vita è un flusso continuo, a cui si oppone la
forma, una ‘maschera’ fissa che blocca la vita e la rende artificiale e porta
inevitabilmente con sé il contrario della vita, ossia la morte. L’uomo
all’interno della società vive una continua lotta contro la forma, le
costrizioni e le maschere che la
società gli impone, che lo rendono estraneo a sé stesso e agli altri.
L’Umorismo
Nel saggio L’umorismo (1908) Pirandello sostiene che
l’atteggiamento più idoneo di fronte alla negatività del mondo è quello ‘umoristico’e
spiega in cosa l’umorismo si distingue dal comico.
Il comico è un “avvertimento del contrario”: vedo che qualcosa è contrario a come dovrebbe essere e rido. L’umorismo è il invece “sentimento del contrario”: vedo qualcosa che è contrario a come dovrebbe essere e rifletto sulle ragioni profonde di quella diversità, su quello che c’è dietro la maschera. Nel primo caso si ha una risata, nel secondo un sorriso amaro consapevole della tragicità del mondo.
Letteratura e metaletteratura
La letteratura, per Pirandello, ha allo stesso tempo una
funzione consolatoria,
proponendosi come gioco umoristico, pur rappresentando la lotta continua tra
vita e forma. Tale scontro si rivela uno scontro tra realtà e finzione, dal momento che la letteratura è di
per sé una finzione, qualcosa che non esiste. Nella metaletteratura teatrale si svela finalmente il gioco
di questa finzione.
Le maschere
nude *
Maschere nude è il titolo della raccolta delle opere
teatrali di Pirandello. L’accostamento dei due termini rimanda ad un paradosso:
sentirsi nudi pur indossando una maschera.
La “maschera”
assolve alla funzione di celare allo sguardo estraneo – ma anche a noi stessi –
la nostra natura più intima e profonda. Ciascuno di noi è più o meno
consapevole di indossare non una, ma diverse maschere sociali, a seconda delle
circostanze in cui ci imbattiamo. Per Pirandello noi possiamo essere ‘uno, nessuno e centomila’.
I personaggi pirandelliani sono maschere
lacerate, frantumate da eventi che costringono a fare i conti con se stessi,
col dolore e col bisogno di esistere al di là della maschera. Esistere, non
sopravvivere.
La Persona è una maschera che rappresenta la
personalità pubblica, quegli aspetti che si palesano al mondo o che l’opinione
pubblica attribuisce all’individuo, in opposizione alla personalità privata che
esiste dietro alla maschera. L’individuo “impersona” un ruolo che gli viene
richiesto dalla società: questo processo gli è funzionale per adattarsi alla
realtà e per semplificare le relazioni sociali.
La ‘persona’
come ‘maschera’
Nell’intera opera pirandelliana troviamo da
una parte la dimostrazione della futilità della maschera sociale, alla quale
rimaniamo ostinatamente ancorati, e dall’altra la paura che sotto la maschera
non possiamo più riconoscere il volto, ossia che non è rimasto nulla di vero ed
autentico in noi.
Sotto la maschera Pirandello svela mondi
multilivello, in cui realtà e fantasia possono coesistere, in cui le regole del
gioco della vita possono essere sovvertite continuamente. Ancorarsi alla
maschera sociale non è che un misero e straziante tentativo per non farsi
sommergere dall’amara consapevolezza che ben poco sappiamo di noi stessi, così
come di quella che consideriamo realtà. Già Freud descriveva l’area della
coscienza come la punta di un iceberg, dove gran parte della nostra psiche
resta sommersa ed impenetrabile alla conoscenza.
Nel tentativo di vedere ciò che sta dietro la
maschera Pirandello sovverte e sradica le fondamenta stesse del teatro: allora
il palcoscenico diventa il luogo in cui assistere allo smascheramento. Questo
comporta confrontarsi con la propria maschera sociale e scoprire il proprio
volto, se c’è e se si trova.
In tutte le opere pirandelliane i personaggi
sono dibattuti dal conflitto tra vita e forma: togliere la maschera permette di
diventare consapevoli spettatori del gioco della vita.
Ma se tutto viene messo in discussione, e vengono
smantellate le finte e vuote certezze, la matrice creativa di Pirandello si
esaurirà nel relativismo e nel nichilismo? «La mia concezione del mondo – dichiara
il nostro Autore - non è per nulla
nihilista, perché ritorna la necessità
dell’assoluto». Da tale necessità deriva il “teatro dei miti”. I miti
rappresentano verità essenziali ed inconfutabili, sedimentate in fondo alla
storia dell’umanità. Esse sono le strutture originarie ed appartengono all’uomo
in ogni tempo e in ogni luogo. E il mito, per Pirandello, ha un volto
femminile, che rappresenta la maternità, la religiosità, l’arte. Non si tratta
di figure rarefatte nell’astrazione della perfezione, bensì di donne concrete,
che pagano col dolore la trasgressione alle convenzioni sociali. Eppure proprio
loro custodiscono il germe della verità.
* (da
Domenica Riccobeni, in Cineterra.it)
____________________________________________________________
Il VI 'Salottino'
del 15 e del 22 gennaio 2019
“L’origine delle specie” (“On
the Origin of Species by Means of Natural Selection”) di Charles Darwin,
pubblicata nel 1859, è considerato uno dei libri fondamentali nella storia
della civiltà occidentale. La teoria dell’evoluzione, in esso illustrata, servì
a liberare la mente dei contemporanei dalla schiavitù delle superstizioni e
delle tradizioni dogmatiche, inaugurando l’era della maturità delle scienze
della vita.
L’idea secondo la quale gli
esseri viventi mutano nel tempo, cioè il concetto fondamentale della teoria
dell’evoluzione, non fu proposta per la prima volta da Darwin. Se ne possono
trovare anticipazioni perfino nell’antichità. Più in particolare, era stato Erasmus
Darwin (nonno di Charles Darwin) a ritenere, verso la fine del XVIII
secolo, che tutti gli animali di sangue caldo si fossero evoluti da un unico
filamento vivente, provvisto del principio vitale direttamente dal Creatore.
Nel 1809, Jean-Baptiste Lamarck
aveva formulato una teoria ‘comportamentale’
dell’evoluzione, insistendo sulle modificazioni indotte nella struttura fisica
degli animali dallo sforzo compiuto dal loro organismo per adattarsi
all’ambiente - modificazioni che poi si sarebbero trasmesse ereditariamente
alle generazioni successive. La giraffa, per esempio, avrebbe sviluppato il suo
lungo, caratteristico collo, attraverso lo sforzo di arrivare a brucare le
foglie di rami sempre più alti, compiuto da intere generazioni di animali della
sua specie.
L’evoluzione delle specie secondo Lamarck
Verso la metà del XIX secolo, Charles
Lyell introdusse il concetto di evoluzione in geologia, sostenendo che
la terra, prima di acquistare il suo volto attuale, era passata attraverso vari
stadi di sviluppo.
E’ significativo come lo Zeitgeist (la cultura del tempo) influisse profondamente sugli eventi dal 1750 al
1850, dato che in quel periodo si cominciò a ragionare in termini evoluzionistici
non solo in biologia ma anche in campo sociale. Come è indicato dalla prima rivoluzione
industriale inglese e da varie rivoluzioni politiche avvenute nel frattempo in
Europa, questa fu un’epoca di rapide trasformazioni politiche e sociali.
Il mutevole clima intellettuale dell’epoca
fece sì che il concetto di evoluzione
acquistasse dignità scientifica. Tuttavia, mentre abbondavano le teorie e le
ipotesi speculative, ben poco era stato fatto sul piano della raccolta di dati concreti.
L’opera di Darwin ‘On the Origin of
Species’, con la sua massa enorme e bene ordinata di osservazioni e di dati,
trasformò l’evoluzione da ipotesi controversa in fatto sconcertante.
Charles Darwin (1809-1882)
Darwin nacque nel 1809 a Shrewsbury, in Inghilterra. Suo padre era medico e il nonno,
Erasmus, si era acquistato fama come filosofo, medico e poeta. Dopo due anni trascorsi a Edimburgo, Darwin
passò a Cambridge dove conseguì il diploma di bachelor of arts nel 1831. Nel periodo trascorso ad Edimburgo
studiò gli invertebrati marini sotto la guida di Robert Grant, uno dei primi naturalisti
convinti della realtà della trasformazione
delle specie.
Uno dei suoi professori, il
botanico John Stevens Henslow, gli
fece ottenere la nomina come naturalista a bordo del brigantino Beagle che il governo inglese stava
allora allestendo per la realizzazione di un viaggio di esplorazione scientifica
intorno al mondo. Questo famoso viaggio, durato dal 1831 al 1836, cominciò
nelle acque dell’America del Sud ed ebbe come tappe successive Tahiti e la
Nuova Zelanda, toccando, al ritorno, l’isola di Ascensión e le Azzorre.
Esso offrì a Darwin l’opportunità
unica di osservare e raccogliere una larghissima varietà di dati sulla vita di
piante e animali, ed egli fece ritorno in Inghilterra con un immenso materiale.
Durante il suo viaggio potè verificare in prima persona le ipotesi
avanzate da Lyell nei suoi ‘Principi di
Geologia’, ossia l’esistenza delle forze naturali che gradualmente
trasformano la superficie del pianeta terra, quali l’erosione, i terremoti e i
vulcani.
Nel 1837, la malferma salute lo
costrinse a ritirarsi in campagna, dove fu in grado di lavorare per non più di
quattro ore al giorno. Nonostante la salute malferma che lo afflisse per tutta la
vita, egli non smise mai di scrivere numerosi articoli e libri scientifici.
Un anno prima della pubblicazione
dell’Origin of Species, Darwin ricevette
una lettera e un manoscritto da un giovane naturalista inglese trasferitosi
nelle Indie orientali, Alfred Russel Wallace, che in sostanza proponeva
la medesima teoria alla cui elaborazione Darwin si era pazientemente dedicato
per ventidue anni: si trattava, evidentemente, di un caso di duplice scoperta
simultanea. Durante una malattia, Wallace aveva tracciato le linee essenziali
di una teoria dell’evoluzione assai simile a quella di Darwin - a quel che si
dice, impiegando soltanto qualche ora! Nella lettera, egli chiedeva il parere
di Darwin e il suo aiuto per la pubblicazione dei risultati del proprio lavoro.
Si può immaginare lo stato d’animo di Darwin, dopo ventidue anni di lavoro
diligente, complesso e tutt’altro che agevole, date le sue condizioni di salute
[1]. Egli si trovò in una
posizione assai delicata, a dir poco. Tra l’altro, la teoria di Wallace non era
corroborata da una così abbondante raccolta di dati come quella di Darwin.
Darwin chiese all’amico Lyell
come dovesse comportarsi e, dietro suo consiglio, decise di dar lettura del
lavoro di Wallace e di alcune porzioni del suo prossimo libro nel corso di un
convegno della Linnean Society,
tenuto il primo luglio del 1858. Dopo questa duplice comunicazione, crebbe
negli ambienti scientifici l’attesa della pubblicazione della teoria
dell’evoluzione nella sua versione completa e definitiva. Le 1250 copie della
prima edizione dell’Origin andarono
esaurite il giorno stesso della loro apparizione in libreria.
La prima edizione dell’Origine delle specie (1859)
L’avvenimento provocò subito forti
entusiasmi e ampie discussioni; non mancarono oppositori che si scagliarono subito
con ingiurie e critiche feroci contro Darwin [2].
Nei due decenni successivi alla
pubblicazione dell’Origin, la
stragrande maggioranza della comunità scientifica cominciò tuttavia ad
accettare il fatto che Darwin avesse ragione riguardo all’evoluzione della
vita, anche se il meccanismo della selezione
naturale spesso non veniva considerato attendibile. Il riconoscimento
ufficiale della validità della selezione
naturale dovette attendere gli anni trenta del Novecento, quando si assistette
alla sintesi fra la teoria darwiniana e la genetica mendeliana.
Charles Darwin era un uomo gentile, affabile, semplice e molto modesto.
Fu sempre fervido in lui il desiderio di comprendere la natura e di far parte
di quel mondo di eccellenza della scienza britannica che tanto rispettava e
amava. Darwin morì nell’aprile del 1882 e fu sepolto nell’Abbazia di
Westminster, accanto a Isaac Newton.
La teoria dell’evoluzione
Darwin, partendo
dalla constatazione della diversità e della somiglianza delle caratteristiche individuali
riscontrabile nei singoli esemplari di una stessa specie, arrivò alla
conclusione che gli esseri viventi fossero
infinitamente variabili.
Al tempo si credeva che le specie fossero state create laddove le si
trovava, in armonia con l’ambiente circostante. Alcuni scienziati avevano
affermato che nel corso della storia le specie erano state generate una sola
volta, mentre i reperti fossili osservati da Darwin durante il suo viaggio sul
Beagle sembravano al contrario dimostrare la nascita di specie differenti in
ere geologiche diverse. Darwin conosceva bene le teorie sulla trasformazione
delle specie esposte anni prima da suo nonno Erasmus e da Lamarck. Ora, però,
le sue idee si stavano dirigendo verso risultati inediti: egli pensava alla
storia della vita non come a una serie di progenie indipendenti, in qualche
modo costrette a progredire dalle monadi alle scimmie, ma come un unico albero
genealogico variamente ramificato. Le somiglianze tra le diverse forme di vita
dovevano dunque provenire da un antenato comune.
Darwin ipotizzò che la
variabilità spontanea delle caratteristiche individuali degli esseri viventi dovesse
trasmettersi per eredità. In natura esiste dunque un meccanismo di ‘selezione
naturale’ che ha come risultato la sopravvivenza degli organismi più
idonei alle esigenze dei rispettivi ambienti, e l’eliminazione di quelli non
idonei. La natura, secondo Darwin, è caratterizzata da una continua lotta per la sopravvivenza e le forme
che sopravvivono sono quelle che sono riuscite a trovare un positivo
adattamento, cioè un migliore aggiustamento alle difficoltà ambientali da esse
incontrate; chi non riesce ad adattarsi è destinato necessariamente a soccombere.
“Gli
organismi viventi sono in equilibrio col loro ambiente, siccome l'ambiente
cambia, debbono cambiare anch'essi, altrimenti sono condannati a scomparire.”
(C Darwin)
Il meccanismo della selezione naturale nella teoria dell’evoluzione
Darwin giunse a formulare il
principio della «lotta per la sopravvivenza»
dopo aver letto l’ ’Essay on the
Principle of Population’, di Thomas Malthus (1789). Malthus aveva
sostenuto che le risorse alimentari crescono in proporzione aritmetica, mentre
la popolazione tende a crescere in proporzione geometrica. Il risultato
inevitabile di questo stato di cose, che il reverendo Malthus definì ‘sgradevole e malinconico’, è che un
gran numero di esseri umani vivono costantemente in condizioni di
sottoalimentazione. Di conseguenza, solo i più robusti e abili riescono a
sopravvivere.
Darwin estese questo principio a
tutti gli organismi viventi, elaborando il concetto di selezione naturale. Gli esseri che sopravvivono alla lotta e
raggiungono la maturità tendono a trasmettere ai loro discendenti le attitudini
o i vantaggi peculiari grazie ai quali essi sono riusciti a sopravvivere.
Inoltre, siccome un’altra legge generale dell’ereditarietà è quella della
variazione, i discendenti presenteranno caratteristiche diverse gli uni dagli
altri, nel senso che alcuni avranno le qualità positive più sviluppale rispetto
ai loro genitori. Queste qualità, a loro volta, tenderanno a sopravvivere, e
nel corso di molte generazioni si potranno verificare notevoli modificazioni
nelle caratteristiche fisiche dei soggetti. In effetti, tali modificazioni
possono essere così sensibili da spiegare le differenze fra le varie specie
animali così come noi oggi le conosciamo.
Molti fanatici religiosi videro una pericolosa minaccia alla fede nella
teoria evoluzionistica di Darwin, poiché la ritenevano in contraddizione con il
racconto biblico della creazione. Ecco qualche esempio di giudizi espressi in
proposito da eminenti personalità ecclesiastiche del tempo: «Un tentativo di
detronizzare Dio»; «Una gigantesca impostura dal principio alla fine»; «Se la
teoria darwiniana è vera, la Genesi è tutta una menzogna, l’intera impalcatura
della Bibbia cade a pezzi e la rivelazione di Dio all’uomo, così come noi
cristiani la concepiamo, è solo un'illusione e un inganno»; uno affermò
sinteticamente (e forse vedendo più chiaramente degli altri nel futuro): «Dio è
morto». Questa infiammata controversia durò molti anni, senza esclusione di
colpi da entrambe le parti.
Dopo un anno dalla pubblicazione del libro, si tenne a Oxford un entusiasmante
dibattito fra Thomas Henry Huxley,
sostenitore di Darwin e della teoria dell’evoluzione, e il vescovo Samuel Wilberforce, che ovviamente difendeva
la versione letterale del libro della Genesi. Wilberforce chiese ad Huxley se
fosse attraverso sua nonna o suo nonno che egli sosteneva di discendere da una
scimmia, formulando così la questione centrale in termini universalmente
comprensibili. Huxley rispose che, come antenato, una scimmia si addiceva molto
di più al vescovo; con queste battute ebbe inizio lo scontro. Scienza e
religione si trovavano ancora una volta l’una di fronte all’altra, in piena
modernità, a contendersi il primato.
Charles Darwin come una scimmia,
in The London Sketch-book
(1874).
Darwin fu, di
fatto, uno scienziato e, relativamente a convinzioni filosofiche e religiose,
nel 1879 scriveva: “la descrizione più esatta del mio stato di spirito è quella
dell’agnostico”. Egli poneva cioè l’accento
sull’impossibilità di trovare nella scienza conferme o smentite decisive a
quelle che erano le tradizionali credenze religiose. Le sue convinzioni
scientifiche e la struttura sistematica della sua teoria erano fondate sull’idea di progresso che
dominava il clima dell’epoca. Grazie all’opera di Darwin, la scienza ha inserito il mondo
degli organismi viventi nella storia progressiva
dell’universo.
Nel 1871 apparve la seconda
importante opera darwiniana sull’evoluzione, cioè “The Descent of Man”. Essa conteneva una rassegna sistematica
di prove a favore della teoria dell’evoluzione dell’uomo da forme inferiori di
vita, mettendo in evidenza la somiglianza fra i processi mentali degli animali
e quelli dell’uomo, e sottolineando l’importanza della selezione sessuale come fattore evolutivo. Darwin studiò in modo
approfondito anche l’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali,
avanzando l’ipotesi che i gesti e le posizioni caratteristici di certi stati
emotivi potessero essere interpretati dal punto di vista evoluzionistico in “The Expression
of the Emotionsin Man and Animals” (1872).
Con queste opere, Darwin dimostrò che non esistevano differenze sostanziali
nei modi di evoluzione tra l’uomo e gli altri animali, ma solo di grado.
Dimostrò cioè l’esistenza di una diversità di gradazione - e non di un divario
incolmabile - non solo tra l’Homo sapiens
e gli altri animali, ma tra tutti gli esseri viventi, il che è una conseguenza
del perenne e continuativo cambiamento che agisce accumulandosi nel tempo.
Darwin
non riuscì a spiegare come si origina la variabilità di caratteri sulla quale
avrebbe agito la selezione naturale. Gli studi dell’abate ceco Gregor Mendel
sull’ereditarietà e i successivi sviluppi della genetica contribuiranno a
confermare l’impalcatura fondamentale delle intuizioni di Darwin e la validità
euristica della teoria dell’evoluzione.
La linea del tempo
dell’evoluzione umana
L'albero genealogico dell'uomo
(dallo Smithsonian's National Museum of
Natural History).
[1] Darwin
aveva sviluppato la sua teoria nel più assoluto segreto, dandone qualche
anticipazionesoltanto a una persona, il dottor Joseph Hooker, nel 1844,
impegnandolo con un giuramento a non farne parola con nessuno.
[2] In
alcuni paesi degli Stati Uniti, si
seguita ancora oggi a parlare di Darwin come dell’iniziatore della teoria
dell’«evilution», cioè di una
dottrina «diabolica» (dall’inglese «evil», diavolo).
______________________________________________
Il V 'Salottino'
Franz Kafka, la metamorfosi
La metamorfosi è un racconto
lungo di Franz Kafka (1883-1924), scritto nel 1912 ma pubblicato
nel 1915. Si tratta di uno
dei testi più noti e famosi dello scrittore boemo in cui si descrivono le vicende
di un uomo, Gregor Samsa,
che una mattina si sveglia e scopre di aver assunto le fattezze di uno
scarafaggio.
Generalmente La metamorfosi è interpretata
come una allegoria della alienazione
dell’uomo moderno all’interno della famiglia e della società, che
si traduce nell’isolamento del “diverso” e nell’incomunicabilità con i propri
simili. Il racconto è anche un
ottimo esempio della poetica e della visione del mondo di Kafka, in cui
il destino dell’esistenza individuale è in mano a forze oscure e inconoscibili,
che operano in maniera assurda e imperscrutabile sulla vita degli uomini (come
si vede anche nel romanzo Il processo).
La metamorfosi è divisa in tre parti e si apre, in modo inatteso e
fulminante, sulla sorprendente
mutazione del protagonista.
Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, Gregor Samsa si
trovò trasformato in un enorme insetto.
Gregor Samsa è un semplice commesso viaggiatore, preciso e metodico, che un mattino,
svegliatosi in ritardo rispetto al solito, si rende conto di aver assunto le
sembianze di un gigantesco
scarafaggio. Il pensiero di Gregor, però, non è inizialmente rivolto al
suo aspetto mostruoso, quanto al consistente ritardo che sta accumulando: la
sua professione lo costringe infatti ad un ferreo rispetto delle coincidenze
ferroviarie e, nelle condizioni in cui si trova, Gregor perderà sicuramente il
treno della mattina.
Gregor vive con i genitori e con un’amata
sorella di sedici anni, di nome Grete, che uno dopo l’altro vanno a bussare alla sua porta, preoccupati
del suo inusuale ritardo e dunque convinti che Gregor sia malato. Il
protagonista, mentre cerca faticosamente di scendere dal letto (egli infatti si
è svegliato riverso sulla schiena, che ora è la sua corazza ricurva), li
rassicura che va tutto bene, sebbene la sua voce sia già modificata dalla sua
nuova condizione.
Gregor finalmente arriva alla porta, proprio quando il procuratore, suo datore di lavoro,
indispettito dall’assenza del suo sottoposto, entra nell’appartamento per avere
notizie di lui. Il procuratore, da dietro la porta, lo sommerge delle accuse
più svariate, tra cui quella di lavorare male da tempo e quella del licenziamento per il suo
comportamento incomprensibile. Gregor vorrebbe ribattere, ma una volta ancora
riesce solo a emettere versi indefiniti. Finalmente, aggrappandosi alla
maniglia con la mandibola, il protagonista riesce ad aprire la porta: il
procuratore, alla vista del ributtante insetto, fugge in preda al panico,
mentre Gregor cerca di inseguirlo per provare a giustificarsi.
La madre di
Gregor, scioccata alla vista del figlio, ha un collasso mentre il padre aggredisce lo scarafaggio a colpi di
bastone, ferendo lievemente Gregor e chiudendo poi a chiave la porta
della camera del figlio. Gregor crolla addormentato.
Nella seconda sezione del racconto, quando ormai siamo al
tramonto della giornata, Gregor si sveglia e trova del pane e del latte che Grete, in un moto di compassione, ha
lasciato lì per lui, impietosita per Gregor e convinta che ci sia ancora una
parte umana in lui. Gregor però, come conseguenza della metamorfosi, ha anche
cambiato gusti alimentari e non ha più appetito per il cibo umano. La sorella,
comprendendo le sue necessità, il giorno dopo gli fa trovare degli avanzi presi dal pattume, che
finalmente Gregor riesce a mangiare.
Le abitudini della famiglia Samsa vengono
così rivoluzionate: Grete, ogni giorno, si reca in camera di Gregor per le
pulizie quotidiane, mentre il fratello-scarafaggio, per non spaventarla, si
rifugia sotto al divano.
Gregor nelle lunghe ore di solitudine in camera ascolta attraverso il muro cosa
sta succedendo nella casa e scopre che, a causa della sua condizione che gli
impedisce di lavorare, i vecchi e stanchi genitori dovranno ricominciare a
lavorare e Grete dovrà abbandonare
le lezioni di violino.
Nel frattempo, Gregor guadagna consapevolezza del
suo nuovo corpo, arrampicandosi sulle pareti e sul soffitto. Grete, premurosa,
decide di togliere i mobili dalla
sua stanza per lasciargli più spazio, sebbene questi siano una
delle ultime prove tangibili della sua precedente condizione di essere umano.
Tuttavia, quando la madre e la sorella stanno sgomberando la stanza del
protagonista, si verifica un grave
incidente: Gregor, accorgendosi che un quadro che gli è molto caro,
raffigurante una donna, sta per essere portato via, esce dal suo nascondiglio,
facendo svenire dall’orrore la madre e facendo esplodere la rabbia di Grete.
Gregor, spaventato e confuso, si sente il responsabile dell’accaduto e gira
freneticamente per casa. Quando il padre, appena tornato dal nuovo lavoro di
fattorino, scopre ciò che è successo, lo assale lanciandogli contro delle mele.
Una di queste gli si conficca nella corazza, ferendolo gravemente ed
impedendolo, di qui in poi, in tutti i suoi movimenti.
Nella terza sezione della Metamorfosi, Gregor è ormai confinato nella sua stanza, divenuta ormai uno sgabuzzino, ed
è sostanzialmente ignorato dalla famiglia: l’appartamento è stato subaffittato
a tre inquilini e la famiglia ha assunto una domestica, che, lungi dall’aver
paura del mostro, lo deride apertamente.
Una sera, mentre Grete suona il violino in salotto per i genitori e
i nuovi ospiti, Gregor esce dalla camera e arriva fino alla soglia della
stanza, affascinato dall’abilità musicale della sorella. La vista dell’insetto,
però, fa trasalire i tre affittuari che lasciano subito l’appartamento. La
situazione economica della famiglia ha quindi un nuovo tracollo e Grete
decide di lavorare come commessa.
Anche la sorella, quindi, smette di prendersi cura del fratello sempre più
convinta dai recenti avvenimenti che non ci sia ormai più traccia dell’amato
fratello in quella bestia, cui rinfaccia di non essersene andata di casa molto
tempo prima. Il padre sostiene apertamente che sia ormai giunto il momento di
sbarazzarsi di Gregor.
Gregor, umiliato ed abbandonato da tutti, dopo aver
ascoltati questi discorsi, si
lascia morire di inedia. La fine di Gregor in realtà è l’inizio di un
nuovo capitolo per la famiglia, che, prendendosi un giorno di riposo, si
concede una gita in campagna. Qui la famiglia Samsa, che già gode
di una certa indipendenza econmica, decide di trasferirsi in una casa più
piccola e più adatta alle proprie esigenza. Grete, nonostante il periodo di
sofferenze trascorso, è diventata una
bella ragazza in età da marito.
(corto animato)
Le pagine della Metamorfosi di Kafka si
presentano come una lunga, articolata metafora che si sviluppa in due direzioni
differenti ma strettamente correlate tra loro. Da un lato, il racconto è una denuncia dell’oppressione delle regole
sociali sull’individuo, che viene schiacciato e spersonalizzato
dalle imposizioni esterne. Dall’altro lato, La metamorfosi è
un apologo sull’impossibilità di
comunicazione tra esseri umani, in particolar modo negli ambienti familiari simboleggiati dai luoghi chiusi ed asfittici in cui si svolge tutta la vicenda.
Gregor Samsa, in cui possiamo vedere un “doppio” del suo
autore, è schiacciato dalle regole
della vita borghese. Il suo lavoro di commesso viaggiatore, ripetitivo e
faticoso, è tuttavia la fonte di sostentamento dell’intera famiglia, circostanza
che lo obbliga ad uno scrupoloso rispetto di obblighi, orari e doveri
d’ufficio. Non a caso, quando appena sveglio capisce d’essersi tramutato in un
ributtante scarafaggio, il primo pensiero di Gregor è al ritardo accumulato già
di prima mattina; quando il procuratore gli intima di aprire la porta della
stanza minacciandolo di licenziamento, Samsa non bada alla reazione che potrà
suscitare il suo nuovo aspetto bestiale, ma cerca in ogni modo di giustificare
il proprio operato e il prorpio comportamento. La metamorfosi in insetto è
insomma la forma concreta
dell’alienazione di Gregor, incastrato in meccanismi che lo privano
della sua identità.
Al tempo stesso, anche il contesto familiare dei Samsa è alla base dell’allegoria
costruita da Kafka: Gregor è il pilastro su cui si regge il loro benessere, esemplificato dalle
lezioni al Conservatorio di Grete. I rapporti di affetto e amore si capovolgono
ben presto quando Gregor non può più assicurare alcuna forma di sostentamento a
causa della sua mutazione; in poco tempo, egli diventa un peso insostenibile e, dopo una
serie di incidenti non voluti da Gregor, anche l’amata sorella lo vede come un
fastidio di cui disfarsi.
In questa situazione emergono facilmente tutte le tensioni latenti, come il difficile
rapporto tra il figlio e il padre, fino all’episodio del ferimento di Gregor a
colpi di mela, o alla circostanza, che prelude alla morte del protagonista, in
cui il giovane ascolta i discorsi dei familiari su tutti i problemi che egli ha
causato alla famiglia.
Tutto ciò - che ha pure precisi riscontri biografici
nell’esistenza di Kafka, figlio di una famiglia di commercianti ma portato alla
carriera letteraria - può farci interpretare La metamorfosi come
l’allegoria dell’impossibile
conciliazione tra le aspirazioni individuali e le costrizioni della vita
borghese.
La “diversità” di
Gregor si carica così di significati e letture che, in parte, restano
volutamente ambigui ed enigmatici, com’è tipico della narrativa kafkiana.
Le cause della metamorfosi non sono spiegate né indagate ed essa
è accettata da Gregor come un dato di fatto; gli altri membri della
famiglia, che rappresentano invece il alto “normale” della vita e della
società, ne sono disgustati, ma nemmeno loro si interrogano sulle cause della
mutazione.
L’effetto di straniamento che ne consegue circonda tutta
la vicenda di un’aura di “realismo magico”: in un contesto apparentemente
reale e quotidiano (l’esistenza di una normale famiglia borghese di inizio
secolo) viene calato un elemento magico o sovrannaturale (la “metamorfosi”),
senza darne spiegazioni razionali. La metamorfosi diventa così per
Kafka la chiave di lettura dei
mali dell’uomo contemporaneo.
Vita e morte
Un'interpretazione della 'Metamorfosi'
________________________________________
Il IV 'Salottino'
del 27 novembre e del 4 dicembre 2018
Federico
Fellini nasce a Rimini il 20 gennaio 1920 da famiglia piccolo-borghese. Il
padre fa il rappresentante di commercio, la madre è una casalinga. Il giovane
Federico frequenta il liceo classico della città ma lo studio non fa per lui.
Comincia allora a procurarsi i primi guadagni come caricaturista: il gestore
del cinema Fulgor, infatti, gli commissiona ritratti di attori celebri da
esporre in pubblico.
Fellini
si trasferisce a Roma nel gennaio 1939, per iscriversi a giurisprudenza. A Roma
frequenta il mondo dell'avanspettacolo e della radio, dove conosce, fra gli
altri, Aldo Fabrizi, Erminio Macario e Marcello Marchesi, e comincia a scrivere
copioni e gag. Alla radio incontra, nel 1943, anche Giulietta Masina (che sta
interpretando il personaggio di Pallina, ideato dallo stesso Fellini) e nell'ottobre
di quell'anno i due si sposano.
Nel
mondo del cinema, Fellini diventa uno degli autori del neorealismo,
sceneggiando alcune delle opere più importanti di quella scuola
cinematografica: con Rossellini, ad esempio, scrive i capolavori "Roma città aperta" e "Paisà"; con Germi "In nome della legge", "Il cammino della speranza" e "La città si difende"; con Lattuada
"Il delitto di Giovanni Episcopo",
"Senza pietà" e "Il mulino del Po". In
collaborazione con Lattuada esordisce alla regia all'inizio degli anni
cinquanta: "Luci del varietà"
(1951) rivela già l'interesse di Fellini per certi ambienti artistici, come
quello dell'avanspettacolo. L'anno successivo Fellini dirige il suo primo film
da solo, "Lo sceicco bianco"
(1952).
Con
"I vitelloni" (1953), il
suo nome varca i confini nazionali. In questo film, il regista ricorre per la
prima volta ai ricordi, all'adolescenza riminese e ai suoi personaggi
stravaganti e patetici.
L'anno dopo, con "La strada" (1954) conquista l'Oscar ed è la consacrazione
internazionale.
Il secondo Oscar arriva con "Le notti di Cabiria" (1957). Come in "La strada", la protagonista è
Giulietta Masina, che qui veste i panni della Cabiria del titolo, una
prostituta ingenua e generosa, che paga con atroci delusioni la fiducia che
ripone nel prossimo.
Con
"La dolce vita"
(1959), Palma d'oro a Cannes e spartiacque della produzione felliniana, si
acuisce l'interesse per un cinema non legato alle tradizionali strutture
narrative. Alla sua uscita il film suscita scandalo, soprattutto negli ambienti
cattolici: gli si rimprovera, assieme ad una certa disinvoltura nel presentare
situazioni erotiche, di raccontare senza reticenze la caduta dei valori della
società contemporanea.
"8½" (1963) rappresenta forse il
momento più alto dell'arte felliniana. Vincitore dell'Oscar per il miglior film
straniero, racconta la storia di un regista che descrive, in modo sincero e
sentito, le sue crisi di uomo e di autore.
In
"Fellini-Satyricon" (1969),
invece, l'impianto onirico è trasferito alla Roma imperiale del periodo della
decadenza. È una metafora del presente, in cui spesso prevale il piacere
goliardico della beffa accompagnato da un interesse per le nuove idee dei
giovani contemporanei.
"Amarcord" (1973), in particolare,
segna il ritorno alla Rimini della sua adolescenza, negli anni trenta. I
protagonisti sono la città stessa con i suoi personaggi grotteschi. La critica
e il pubblico lo acclamano con il quarto Oscar.
A
questo film gioioso e visionario si susseguono "Il Casanova" (1976),
"Prova d'orchestra" (1979), "La
città delle donne" (1980) "E
la nave va" e "Ginger e
Fred" (1985).
L'ultimo
suo film è "La voce della Luna"
(1990), tratto da "Il poema dei lunatici" di Ermanno Cavazzoni.
Nella
primavera del 1993, qualche mese prima di morire, Fellini riceve il suo quinto
Oscar, alla carriera. Federico Fellini si spegne a Roma, per un infarto, il 31
ottobre 1993 all'età di 73 anni.
_________________________________________________
Il III 'Salottino'
del 13 e del 20 novembre 2018
Il Cantico dei Cantici o semplicemente Cantico (ebraico שיר השירים, shìr
hasshirìm, Cantico sublime; greco
ᾎσμα ᾈσμάτων, ásma asmáton; latino Canticum Canticorum) è un poema
contenuto nella Bibbia ebraica (Tanakh) e cristiana.
Il Cantico dei Cantici è uno dei testi più
antichi di tutte le letterature. Attribuito a Salomone - antico
re di Israele del
X secolo a.C., celebre
per la sua saggezza, per i suoi canti e anche per i suoi amori - fu composto
non prima del IV secolo a.C. ed è uno degli ultimi testi accolti nel canone
della Bibbia, addirittura un secolo dopo la nascita di Cristo.
È
composto da 8 capitoli contenenti poemetti d'amore in forma dialogica tra un
uomo ("Dodì”, l’Amato) e una donna (la "Sulammita").
Il
nome del libro, con la ripetizione della parola cantico, secondo il modo
di costruire le frasi degli antichi ebrei, è da considerarsi come un
superlativo e andrebbe reso come ‘il più sublime tra i cantici’.
Il Cantico è un testo laico derivato da
alcuni poemi della Mesopotamia, un canto nuziale nel quale la parola ‘Dio’ non
è mai menzionata.
Il Cantico dei Cantici rappresenta uno dei
testi più lirici e inusuali delle Sacre scritture. Sebbene rappresenti in versi
l'amore tra due innamorati, con tenerezza ma anche con un ardire di toni ricco
di sfumature sensuali e immagini erotiche, non pregiudica tutttavia il suo carattere sacro, in quanto
l'amore erotico dei due amanti, per l'autore, ha origine divina.
Il
testo non si presta a una lettura lineare, in quanto manca di quella
conseguenzialità espositiva che consenta di seguire una qualche traccia nello
sviluppo del dialogo amoroso tra i due protagonisti. Il Cantico si svolge con l’andamento del sogno: oniriche sono le
immagini, e squisitamente onirica è l’atmosfera emotiva che trascorre per tutto
il testo.
L'interpretazione
del Cantico (come per tutti i testi
sacri) non va intesa solo in senso letterale, poiché nasconde certamente un
significato allegorico ed iniziatico che trascende la semplicità dei versi
d'amore che lo compongono.
Nel
tempo, molteplici sono state le interpretazioni del testo, sia da parte della
dottrina ebraica che cristiana, a riprova della grande considerazione che il Cantico ha sempre avuto nelle due
religioni. Tra le interpretazioni allegoriche più diffuse abbiamo, nel primo
caso, quella dell'amore del creatore per il suo popolo (Israele),
nel secondo caso dell'amore tra Cristo e
la Chiesa,
sua sposa.
Il
testo ha un altissimo valore nell'ebraismo, essendo il Cantico uno dei "Meghillot", i "rotoli"
letti in occasione delle principali feste: il Cantico, proprio per la sua importanza, è stato assegnato alla Pasqua.
Nella
religione ebraica, per la santità del contesto e del suo significato simbolico,
il testo viene paragonato al luogo più santo ed interno del Tempio di
Gerusalemme: il Cantico dei
Cantici infatti include metaforicamente tutta la Torah.
Dal ciclo “Il Cantico
dei Cantici” (IV) di Marc Chagall
* * *
CANTICO DEI CANTICI
Il canto più bello di Salomone
Il canto più bello di Salomone
I
LEI
2 Che lui mi baci
con i baci della sua bocca.
Più dolci del vino sono le tue carezze,
3 più inebrianti dei tuoi profumi.
Tu stesso sei tutto un profumo.
Vedi, le ragazze si innamorano di te!
4 Prendimi per mano e
corriamo.
Portami nella tua stanza, o mio re.
Godiamo insieme, siamo felici.
Il tuo amore è più dolce del vino.
A ragione le ragazze s’innamorano di te!
"...mi baci coi baci della sua bocca..." (acrilico di Rosa Soravito, 2014)
5 Ho la pelle scura
eppure sono bella, ragazze di Gerusalemme, scura
come le tende dei beduini’,
bella come i tendaggi del palazzo di Salomone.
6 Non state a
guardare se sono scura, bruciata dal sole.
I miei fratelli si sono adirati
con me;
mi hanno messa a guardia delle vigne, ma la mia vigna io
l’ho trascurata.
7 Dimmi, amore mio,
dove vai a pascolare il tuo gregge, a mezzogiorno dove lo
fai riposare?
Io non voglio cercarti tra i greggi
dei tuoi amici, come una vagabonda!
I pastori
8 O bellissima tra le donne, non conosci il
posto?
Segui le orme del
gregge, porta le tue caprette al pascolo vicino alle tende dei pastori.
LUI
5 Amica mia,
sei come una puledra
che fa impazzire i cavalli del faraone!
10 Come son belle le
tue guance, tra le trecce,
com’è bello il tuo collo ornato di perle!
com’è bello il tuo collo ornato di perle!
11 Ti faremo una
collana d’oro, con ornamenti d’argento.
LEI
12 Ora che il mio re è
qui nel suo giardino
Il mio profumo di nardo si spande
tutt’intorno.
13 Amore mio,
sei come un sacchetto di mirra, e di notte riposi fra i miei
seni.
14 Amore mio,
sei come un mazzo di fiori cresciuti nelle vigne di Engaddi.
LUI
Quanto sei bella, amica mia,
quanto sei
bella, i tuoi occhi sono come colombe!
LEI
16
Anche tu, amore mio, quanto sei bello, meraviglioso sei.
Un prato d’erbe è il nostro letto,
rami di cedro sono le travi della nostra casa,
rami di pino il suo soffitto.
II
Io sono un narciso della pianura di
Saron, un giglio delle valli.
LUI
3 Sì, un giglio tra le
spine è la mia amica tra le altre ragazze!
LEI
3
Un melo tra alberi selvatici è il mio amore tra gli altri ragazzi!
Mi piace sedermi alla sua ombra e gustare le delizie dei suoi
frutti.
4 Mi ha portato in una
sala di banchetti;
in alto, sopra di me, c’era un’insegna con sopra scritto: «Amore».
5 Presto; portate
dolci d’uva che mi restituiscano forza,
mele, che mi diano sostegno
perché sono malata d’amore!
6 II suo braccio
sinistro è intorno al mio collo, e con il destro mi abbraccia.
7 Ragazze di Gerusalemme,
Io vi
scongiuro,
per le gazzelle e le cerve dei campi; non risvegliate il
nostro amore',
non provocatelo prima del tempo.
8-9
Sento la voce del mio amore, eccolo, arriva!
Salta per le montagne, come fa la gazzella; corre sulle
colline,
veloce come un cerbiatto.
Eccolo, sta dietro al nostro muro;
guarda dalla finestra, spia dalle persiane.
10 Ora, il mio amore mi parla:
LUI
Andiamo, amica mia, mia bella, vieni.
11 È finito l’inverno,
sono terminate le piogge.
12 Già spuntano i
fiori nei campi, la stagione del canto ritorna.
Si sente cantare la tortora.
13 I fichi già danno
i primi frutti, le viti sono in fiore
e mandano il loro profumo. Andiamo,
amica mia, mia bella, vieni.
14 Colomba mia,
nascosta nelle fessure delle rocce, in nascondigli segreti,
fammi vedere il tuo viso, fammi ascoltare la tua voce;
LEI
15 Catturateci le
volpi; le piccole volpi
che ci rovinano le vigne proprio ora che sono fiorite.
16 II mio amore è mio
come io sono sua.
Egli si diletta tra i gigli.
17 Prima che soffi la
brezza della sera e le ombre si allunghino,
ritorna, amore mio, tra le colline
veloce come una gazzella o un cerbiatto.
III
LEI
'Di notte, nel mio letto, ho
cercato il mio amore.
L’ho cercato, ma non l’ho trovato.
2 Mi alzerò, farò il giro della città!
Per strade e per piazze devo cercare il mio amore.
L’ho cercato, ma non l’ho trovato.
3 Ho incontrato le
guardie che facevano la ronda in città.
Ho chiesto loro:
«Avete visto il mio amore?».
4 Le avevo appena
lasciate ed ecco
ho trovato il mio amore.
L’ho stretto forte a me e non lo lascerò più.
Lo porterò in casa mia nella stanza dove mia madre mi ha
concepita.
5 Ragazze di
Gerusalemme, io vi scongiuro
per le gazzelle e le cerve dei campi: non risvegliate il
nostro amore",
non provocatelo prima del tempo.
non provocatelo prima del tempo.
Il coro
6 Chi sta arrivando dal deserto,
come una nube di
fumo,che spande profumo di mirra'1, di incenso,
e di tutti gli aromi
più rari?
7 È la lettiga del re Salomone", circondata
da sessanta soldati,
i più coraggiosi d’Israele.
8 Son tutti armati di spada e allenati a
combattere.
Portano al fianco la
spada.
Stanno in guardia contro
i pericoli della notte.
9 La lettiga del re Salomone è in legno di
cedro.
10 Le colonne sono d’argento,
lo
schienale d’oro,
il
sedile tutto di porpora4.
Le ragazze di
Gerusalemme
hanno adornato con
amore l’interno.
" Ragazze di Sion', uscite a vedere il
re Salomone.
Porta la corona che
gli ha messo sua madre il giorno delle sue nozze,
il giorno della sua
gioia e della sua felicità.
IV
LUI
Quanto sei bella, amica mia, quanto
sei bella!
I tuoi occhi, dietro il velo, sono come colombe.
I tuoi capelli ondeggiano come un gregge
che scende dalle pendici del Galaad".
2 I tuoi denti mi fanno pensare a un gregge di
pecore da tosare, appena lavate.
Tutte in fila, una accanto all’altra, e non ne manca
nessuna.
3
Un nastro di porpora sono le tue labbra!
Com’è bella la tua bocca!
Dietro il velo, le tue guance sono rosse
come uno spicchio di melagrana.
4
II tuo collo è come una fortezza, come la Torre di Davide;
mille scudi vi sono appesi, sono gli scudi
degli eroi!
3
I tuoi seni sembrano cerbiatti o gemelli di una gazzella che pascolano tra i
gigli.
6 Prima che soffi la
brezza della sera o le ombre si allunghino,
verrò di
certo alla tua montagna profumata di mirra e alla tua collina d’incenso.
7 Sei bellissima,
amica mia, sei perfetta.
8 Vieni con me, mia
sposa,
lascia i monti del Libano, vieni con me.
Scendi dalle
cime dell’Amana,
del Senir e
dell’Ermon,
fuggi queste
tane di leoni e di leopardi!
9 Mi hai preso il
cuore, sorella mia, mia sposa,
mi hai preso il cuore, con un solo tuo sguardo,
con una sola perla della tua collana!
10 II tuo amore,sorella mia, mia sposa, è così
bello,
molto più
dolce del vino!
Il tuo
profumo è più gradevole di tutti gli aromi.
11 Le tue labbra sanno
di miele, mia sposa,
la tua
lingua ha il sapore del miele e del latte.
Le tue vesti
hanno il profumo del Libano.
12 Sorella mia, mia
sposa, sei come un giardino recintato e chiuso,
come una sorgente inaccessibile.
13 Le tue nascoste
bellezze sono un giardino di melograni,
dai frutti squisiti, con piante di Cipro,
14 nardo e zafferano,
cannella e cinnamomo,
ogni specie di piante d’incenso, mirra e aloè” e tutti i profumi più
rari.
15 Tu sei una sorgente di giardino,
LEI
16 Alzati, vento del
nord, vieni, vento del sud,
spandete i profumi del mio giardino.
E tu, amore mio,
vieni nel tuo giardino, gusta i suoi frutti squisiti!
V
LUI
'Sono venuto nel mio giardino, sorella mia, mia sposa.
Raccolgo la mia mirra e le mie erbe profumate.
Mangio il miele del mio favo, bevo il mio latte e il mio
vino.
Il Coro
«Mangiate, amici,
bevete, inebriatevi
d’amore'».
LEI
Mi sono addormentata, ma resta sveglio il mio cuore.
Sento qualcosa: è il mio amore che bussa! che chiede:
«Aprimi, sorella, amica mia, bellissima colomba!
3 Mi sono appena
spogliata,
dovrei rivestirmi?
Mi sono appena lavata i piedi,
perché dovrei sporcarli di nuovo?
4 II mio amore cerca
di aprire la porta: che tuffo al cuore!
Salto in piedi per aprire al mio amore.
Le mie dita e le mie mani gocciolano olio di mirra
quando alzo il chiavistello.
6 Ho aperto al mio
amore, ma è partito, non c’è più.
È partito, e io ne sono sconvolta.
Lo cerco, ma non riesco a trovarlo.
Lo chiamo, ma lui non risponde.
7 Mi incontrano le guardie
che fanno la ronda sulle mura della città.
Mi picchiano, mi feriscono, mi strappano lo scialle.
8 Ragazze di
Gerusalemme, vi supplico,
se trovate il mio amore,
ditegli che io sono malata d’amore.
Ragazze
9 «Puoi dirci,
tu che sei la più
bella, cos’ha il tuo amore
di diverso dagli
altri?
È davvero tanto
diverso, che ci supplichi così?».
LEI
10 II mio amore è bello e forte,
lo si riconosce tra mille.
Il suo volto
è come l’oro più puro,
i suoi
capelli sono folti e ricciuti, neri come il corvo.
12 I suoi occhi sono
colombe accanto a un ruscello.
Le sue pupille galleggiano sul latte,
come colombe su uno specchio d’acqua.
13 Le sue guance sono aiuole
di piante profumate e di spezie.
Le sue labbra sono gigli, bagnate di olio di mirra.
14 Le sue mani sono
anelli d’oro carichi di pietre preziose.
Il suo petto è una piastra d’avorio
coperta di zaffiri.
15 Le sue gambe sono colonne di marmo bianco
poggiate su basi d’oro puro.
Egli ha l’aspetto delle montagne del Libano,
è magnifico come gli alberi di cedro.
16 La sua bocca è
dolcissima;
tutto, in lui, risveglia il mio desiderio.
Ecco, così è il mio amore, il mio amico, ragazze di
Gerusalemme!
VI
Ragazze
‘«Dov’è andato il tuo
amore, o bellissima?
Puoi dirci che
direzione ha preso,
così possiamo cercarlo
con te?».
LEI
2 II mio amore è venuto a godersi il suo giardino,
a raccogliere gigli
tra aiuole di piante profumate.
3 Io sono del mio
amore e il mio amore è mio.
Egli si diletta tra i gigli.
LUI
4 Amica mia, sei bella
come la città di Tirsa,
splendida come Gerusalemme, affascinante come un miraggio.
5 Allontana gli occhi
da me, il tuo sguardo mi turba.
I tuoi capelli ondeggiano come un gregge
che scende giù dalle pendici del Galaad.
6 I tuoi denti mi fanno pensare
a un gregge di pecore appena lavate,
tutte in fila, una accanto all’altra, e non ne manca
nessuna.
7 Dietro il velo
le tue guance sono rosse come spicchi di melagrana.
8 II re abbia pure
sessanta regine, ottanta altre donne
e ragazze quante ne vuole!
9 Per me c’è solo lei,
la mia stupenda colomba, unica figlia di sua madre, sua
delizia.
«Come sei fortunata!» dicono le altre ragazze quando la incontrano.
"... bella come l'urora, affascinante come un miraggio ..."
«Come sei fortunata!» dicono le altre ragazze quando la incontrano.
Anche le regine e le concubine la lodano e si domandano:
10 «Chi è mai questa
ragazza amabile come l’aurora, bella come la luna,
splendente come il sole, affascinante come un miraggio?».
" Sono
sceso nel parco dei noci, fin giù nella valle,
sono andato a
vedere se le viti germogliano, se i melograni sono in fiore.
12 Ma ora non mi
riconosco più: mi hai conquistato, figlia di prìncipi"!
VII
Il coro
«Voltati, voltati, Sulamita,
voltati, voltati, e lasciati guardare! ».
LUI
È bella, vero, la Sulamita
nella «danza delle due schiere»!
2 Come sono belli i
tuoi piedi nei sandali, principessa.
Le curve dei tuoi fianchi sono davvero un’opera d’arte.
3 Lì c’è una coppa
rotonda: che non manchi mai di vino profumato!
Il tuo ventre è come un mucchio di grano circondato di
gigli.
4 I tuoi seni sono
come due cerbiatti o due gemelli di una gazzella.
5 II tuo collo
assomiglia alla Torre d’avorio.
I tuoi occhi sembrano i laghetti di Chesbon,
vicino alla porta di Bat-Rabbim.
Il tuo naso è come la Torre del Libano,
che sorveglia la città di Damasco.
6 La tua testa si
erge fiera come il monte Carmelo.
I tuoi capelli hanno riflessi color
porpora;
un re è stato preso dalle tue
trecce!
7 Quanto sei bella,
come sei graziosa,
amore mio, delizia mia.
amore mio, delizia mia.
8 Sei slanciata come una palma,
i tuoi seni sembrano grappoli di datteri.
9 Voglio salire sulla
palma e raccogliere i suoi frutti!
I tuoi seni siano per me come grappoli d’uva;
il profumo del tuo respiro come l’odore delle mele
10 e la tua bocca come
il buon vino...!
LEI
... Sì, un buon vino,
tutto per il mio amore,
scivoli sulle nostre labbra addormentate!
11 Io sono del mio
amore e lui mi desidera.
12 Vieni, amore,
andiamo nei campi, passiamo la notte tra i fiori.
13 Al mattino presto
saremo già nelle vigne,
a vedere se germogliano, se le gemme si schiudono,
se i melograni sono in fiore.
Laggiù ti darò il mio amore.
14 Le mandragole
mandano il loro profumo.
Alla nostra porta abbiamo ogni specie di frutti deliziosi, secchi e
freschi.
Amore mio, li ho conservati per te.
VIII
Come vorrei che tu fossi mio fratello, allattato da mia madre.
Incontrandoti per via potrei abbracciarti senza essere
rimproverata.
2 Ti porterei in casa
e tu mi insegneresti l’amore.
Ti farei assaggiare il mio vino profumato e il mio succo di
melagrana.
3 II suo braccio
sinistro è intorno al mio collo,
con il destro mi abbraccia.
4 Ragazze di
Gerusalemme, vi supplico:
non risvegliate il nostro amore, non provocatelo prima del
tempo.
Ragazze
«Chi è quella ragazza che arriva dal deserto
LEI
Ti ho svegliato sotto il melo,
lì dove tua madre ti ha concepito.
6
Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio.
Perché l’amore è forte come la morte,
la passione è irresistibile come il mondo dei morti.
È una fiamma ardente come il fulmine'.
7 Non basterebbe l’acqua degli oceani a spegnere l’amore.
Neppure i fiumi lo potrebbero sommergere.
Se qualcuno provasse a comprare l’amore con le sue ricchezze
otterrebbe solo il disprezzo.
I fratelli
* «Nostra sorella è molto giovane,
non ha quasi seno!
Che cosa faremo per
lei quando le faranno la corte?
9 Se fosse un muro costruiremmo su di lei delle
torri d’argento.
Se fosse una porta,
la rinforzeremmo con
assi di pino».
LEI
10 Se io sono un muro,
i miei senisono già come torri.
i miei senisono già come torri.
Ma il mio amico lo accolgo
e gli voglio dar pace.
LUI
11 Salomone ha una
grande vigna a Baal-Amon,
e l’ha affidata a dei guardiani.
Ciascuno gli versa in frutto mille pezzi d’argento.
12 Tieni pure i tuoi
mille pezzi d’argento, Salomone,
danne duecento ai tuoi guardiani.
La mia piccola vigna è qui, ed è tutta per me.
13 Bella mia, che stai nel giardino,
i miei amici cercano di ascoltare
quel che stai dicendo.
Fai sentire anche a me!
LEI
14 Corri, amore,
veloce
come una gazzella o un cerbiatto sui monti profumati1’.
(Traduzione a cura dell’ABU
– Alleanza Biblica Universale - L.D.C.
Ed, Leumann-Torino,1985)
Il Cantico dei Cantici , un sogno d'amore
* * *
Sul “CANTICO DEI CANTICI”
di Gianfranco Ravasi
«Non c’è
nulla di più bello del Cantico dei
cantici»: queste parole sono pronunziate da uno dei personaggi de L’uomo senza qualità, il
capolavoro dello scrittore austriaco Robert Musil (1880-1942),
grande testimone della crisi europea del Novecento. Esse esprimono
l’ammirazione incondizionata che ha goduto questo libretto biblico di sole 1250
parole ebraiche. Un poemetto che ha meritato appunto il titolo di Shir hasshirim, Cantico dei cantici, un modo
semitico per esprimere il superlativo: il “cantico” per eccellenza, il “canto
sublime” dell’amore e della vita.
Il massimo
teologo protestante del Novecento, Karl Barth, non aveva esitato a definire
questo scritto «la magna charta
dell’umanità». Eppure questa «charta» del nostro essere uomini capaci di
amare, di godere ma anche di soffrire, non è sempre stata letta in modo
uniforme perché le sue sfaccettature sono molteplici e variegate come quelle di
una pietra preziosa. Sembra aver ragione un antico rabbino, Saadia ben Joseph
(882-942), il quale comparava il Cantico
a una serratura di cui si è persa la chiave: per aprirla si devono moltiplicare
i tentativi.
La chiave
indispensabile per schiudere questo scrigno è, però, come spesso accade, la più
immediata. Per comprendere il senso fondamentale di questo libro in cui Dio
parla il linguaggio degli innamorati, è necessario usare la chiave delle sue
parole poetiche, cioè di quello che un tempo si era soliti definire il senso
letterale. Infatti l’opera raccoglie il gioioso dialogo di due persone che si
amano, che si chiamano per 31 volte dodî,
“amato mio”, un vezzeggiativo molto simile a quei nomignoli che gli innamorati
si coniano segretamente per interpellarsi.
Nel Cantico la donna e l’uomo trovano
tutta la freschezza e l’intensità di una relazione che essi stessi vivono e
sperimentano attraverso l’eterno miracolo dell’amore. È una relazione intima e
personale, costruita sui pronomi personali e sui possessivi di prima e seconda
persona: «mio/tuo», «io/tu». La sigla spirituale e “musicale” del Cantico è in quella folgorante
esclamazione della donna: dodî lî
wa’anî lô, «il mio amato è mio e io sono sua» (2, 16). Esclamazione
reiterata e variata in 6, 3: ’anî ledodî
wedodî lî, «io sono del mio amato
e il mio amato è mio». È la formula della pura reciprocità, della mutua
appartenenza, della donazione vicendevole e senza riserve.
Questa
perfetta intimità passa attraverso tre gradi. Conosce la bipolarità sessuale
che è vista come “immagine” di Dio e realtà «molto buona/bella», secondo la Genesi (1, 27 e 31), cioè
rappresentazione viva del Creatore attraverso la capacità generativa e di amore
della coppia. Ma la sessualità da sola è meramente fisica. L’uomo può salire a
un grado superiore intuendo nel sesso l’eros, cioè il fascino della bellezza,
l’estetica del corpo, l’armonia della creatura, la tenerezza dei sentimenti.
Con l’eros, però, i due esseri restano ancora un po’ “oggetto”, esterni l’uno
all’altro.
È solo con
la terza tappa, quella dell’amore, che scatta la comunione umana piena che
illumina e trasfigura sessualità ed eros. E sono soltanto la donna e l’uomo fra
tutti gli esseri viventi che possono percorrere tutte queste tappe giungendo
alla perfezione dell’intimità, del dialogo, della donazione d’amore totale.
Nel Cantico è in scena, quindi,
l’amore tenero, “primaverile”, presente non solo nella coppia bella di due
giovani innamorati ma, potremmo dire, anche nell’immutata tenerezza di una
coppia anziana ancora innamorata. Un primato è assegnato soprattutto alla
femminilità perché nel Cantico
la donna è più protagonista dell’uomo, nonostante il sedimentato maschilismo
dell’oriente da cui l’opera proviene.
Significativa
per il nostro tema è l’attenzione riservata al volto dei due innamorati. Certo,
tutto il corpo - inteso come segno di comunicazione - è coinvolto nel poema: ci
sono le braccia, la mano e le dita, il cuore, il seno, il ventre, i fianchi,
l’ombelico, le gambe, i piedi, le carezze, la pelle scura. Ma centrale è il
volto, descritto in tutti i suoi tratti: dal capo al collo, dalle guance agli
occhi, dalla bocca alle labbra, dal palato ai denti, dai capelli fino ai
riccioli. È il volto il segno più vivo e autentico del dialogo, dell’incontro,
della comunione di vita, pensiero e sentimento.
Il Cantico è, poi, un inno continuo
alla gioia di vivere: quando il cielo è spento dalle nuvole - scriveva Paul
Claudel - la superficie di un lago è piatta e metallica; quando brilla il sole
essa si trasforma in uno specchio mirabile delle tinte del cielo e della terra.
Così, infatti, è della vita dell’uomo quando si accende l’amore: il panorama è
sempre lo stesso, il lavoro è sempre monotono e alienante, le città anonime e
fredde, i giorni identici l’un l’altro; eppure l’amore tutto trasfigura e
allora si ama e si vede tutto con occhi diversi perché l’uomo sa che alla sera
incontrerà la sua donna.
L’amore
umano, però, conosce anche la crisi, l’assenza, la paura, il silenzio, la
solitudine. Ci sono nel Cantico
due scene notturne (3, 1-5 e 5, 2 - 6, 3) piene di tensione in cui l’uomo e la
sua donna sono lontani e si cercano disperatamente senza ritrovarsi. L’apice
del poema biblico è in 8, 6 ove si mette in tensione dialettica amore e morte:
«Potente come la morte è amore, / inesorabile come gli inferi la passione: / le
sue scintille sono scintille ardenti, / una fiamma del Signore» (curiosamente è
l’unico verso del Cantico
in cui risuoni il nome divino Jah/Jhwh). In quel duello estremo il poeta sacro
è certo che l’amore debba prevalere, come Dio è vincitore della morte e del
male.
Il Cantico è, quindi, prima di tutto
la celebrazione dell’amore umano e del matrimonio. Tuttavia, in questo amore il
poeta biblico intravede quasi un seme dell’amore eterno e perfetto con cui Dio
ama la sua creatura. Non dimentichiamo, infatti, che già il profeta Osea
nell’VIII secolo prima dell’era cristiana, aveva usato la sua drammatica
esperienza matrimoniale e familiare trasformandola in una parabola dell’amore
di Dio per il suo popolo Israele (Osea,
1-3). Questa trasmutazione tematico-simbolica appare implicitamente anche nel Cantico.
All’interno
dell’amore umano - e non prescindendo da esso, come si è fatto invece nella
cosiddetta lettura “allegorica” che ha ridotto il Cantico a una larva spiritualeggiante - dobbiamo
cogliere un segno ulteriore, quello dell’amore trascendente di Dio per la sua
creatura. È il secondo livello interpretativo attraverso il quale il Cantico è diventato anche il
testo della mistica cristiana: citiamo solo i Pensieri sull’amore di Dio di santa Teresa d’Avila e
quel capolavoro letterario e mistico che è il Cantico spirituale di san Giovanni della Croce, che si
alimentano al Cantico dei cantici.
La
rappresentazione plastica più famosa di questo intreccio spirituale potrebbe
essere l’Estasi di santa Teresa
del Bernini nella chiesa romana di Santa Maria della Vittoria: un angelo lancia
la freccia dell’amore divino verso la santa che è immersa in un’estasi fisica e
interiore di altissima intensità, spirituale e sensuale. La vergine amante si
abbandona a Dio attraverso un amore incandescente che pervade tutto l’essere,
anche fisico.
Ma nella
Bibbia il testo che maggiormente fa risplendere la meraviglia dell’amore umano
e il suo valore di segno teologico è proprio il Cantico. Dio, infatti, come insegna la prima lettera
di san Giovanni, «è amore». Un antico testo giudaico commentava così il viaggio
di Israele nel deserto del Sinai: «Il Signore venne dal Sinai per accogliere
Israele come un fidanzato va incontro alla sua fidanzata, come uno sposo
abbraccia la sua sposa».
Il Cantico, quindi, deve
accompagnare gli innamorati nelle tappe oscure e serene, nel riso e nelle
lacrime di quella stupenda vicenda che è il loro amore. Ma il Cantico è nella sua meta
terminale la figura suprema dell’amore tra Dio e la sua creatura, per cui esso
diventa un testo capitale soprattutto per tutti i credenti. Perciò, aveva
ragione il grande scrittore cristiano del iii secolo Origene di Alessandria
quando scriveva: «Beato chi comprende e canta i cantici delle Sacre Scritture!
Ma ben più beato chi canta e comprende il Cantico dei
cantici!».
Il Cantico
dei Cantici , il più bel canto d'amore
* * *
Risveglio
In un'alba triste,
la felicità della prima coppia appena creata svanisce insieme alla loro innocenza.
L'Eden è perduto per sempre.
Il primo peccato, la superbia, porterà presto frutti di violenza e di morte.
I fratelli uccideranno i fratelli
e un fiume di sangue inonderà tutta la terra.
Nei riverberi della memoria
la nostalgia del paradiso,
nel risveglio della storia
il contrappunto di un dolore senza fine.
Il cantico dei cantici
di I. Kambanellis - M. Theodorakis
( clip di Leoncarlo Settimelli)
la felicità della prima coppia appena creata svanisce insieme alla loro innocenza.
L'Eden è perduto per sempre.
Il primo peccato, la superbia, porterà presto frutti di violenza e di morte.
I fratelli uccideranno i fratelli
e un fiume di sangue inonderà tutta la terra.
Nei riverberi della memoria
la nostalgia del paradiso,
nel risveglio della storia
il contrappunto di un dolore senza fine.
Il cantico dei cantici
di I. Kambanellis - M. Theodorakis
( clip di Leoncarlo Settimelli)
____________________________________________
Il II 'Salottino'
del 23 ottobre e del 6 novembre 2018
Maurits
Cornelis Escher
(Leeuwarden,
17 giugno 1898 – Laren, 27 marzo 1972)
Il nome di Escher, grafico e
disegnatore, è indissolubilmente legato alle sue incisioni su legno, litografie
e mezzetinte che tendono a presentare costruzioni impossibili, esplorazioni
dell'infinito, tassellature del piano e dello spazio e motivi a geometrie
interconnesse gradualmente cangianti in forme via via differenti.
Le opere di Escher sono molto amate dagli scienziati, logici, matematici
e fisici che apprezzano il suo uso razionale di poliedri, distorsioni
geometriche ed interpretazioni originali di concetti appartenenti alla scienza,
sovente per ottenere effetti paradossali.
* * *
Il giovane
Maurits, per le varie materie insegnate a scuola, rivelò un interesse saltuario
e inadeguato, tanto che dovette ripetere più volte lo stesso anno scolastico. Da
studente, fu sempre sottovalutato dai suoi insegnanti: «Escher è troppo
ostinato, troppo filosofico-letterario: al ragazzo mancano vivacità e
originalità: è troppo poco artista».
A 24 anni
Escher visitò l'Italia in compagnia di alcuni suoi amici. Stregato dalla
bellezza italica, vi ritornò nell'autunno dello stesso anno, imbarcandosi su
una nave diretta a Genova. Da Genova si spinse poi sino a Siena. Piacevolmente colpito dalla città e dalle
verdeggianti campagne toscane, a Siena eseguì le prime incisioni lignee su
paesaggi italiani (sotto, l'incisione "Paesaggio intorno a Siena, 1923)
Nel 1923
Escher si trasferì presso la costiera amalfitana. Restò folgorato dalla suadente plasticità
della luce del Mezzogiorno e, soprattutto, dalla commistione di elementi
romani, greci e saraceni presente nelle architetture di Ravello e Amalfi, città
campane che lasciarono un'impronta profonda nella sua fantasia.
Dopo il
matrimonio con Jetta Umiker (1924) si stabilì a Roma. L'artista visse anni
idillici in Italia, che divenne per lui una seconda patria dove ritenne di
poter maturare tranquillamente la propria fisionomia artistica.
Negli anni
trenta, in Italia, il Fascismo aveva definitivamente consolidato il propri
connotati di regime totalitario. Un clima politico così teso e cupo era
insopportabile per Escher, che vacillò del tutto quando nel 1935 vide il figlio
George tornare a casa con l'uniforme di Piccolo Balilla. Questo evento,
apparentemente insignificante, costituì per Escher la classica goccia che fece
traboccare il vaso: perciò egli lasciò istantaneamente il paese, trasferendosi
con la famiglia in Svizzera.
Escher
rimase «in questo tremendo paesaggio
misero e bianco» un anno: il paesaggio elvetico non lo ispirava per nulla.
I monti gli sembravano pietraie senza storia, blocchi rocciosi senza vita.
Tutto, intorno a lui, era l'opposto dell'Italia Meridionale, che tanto aveva
catturato il suo sguardo. I tempi erano ormai maturi per fare ritorno alla
suadente mitezza del Mar Mediterraneo: nel 1936 intraprese un breve viaggio in
Spagna. Questo viaggio fu importantissimo per la maturazione grafica di Escher.
A Granada, infatti, egli si imbatté nell'Alhambra, il complesso palaziale
moresco i cui interni sono ornati con arabeschi e motivi grafici ricorsivi. La
ricezione delle tassellazioni moresche fu seguita da risvolti sensazionali
nella grafica escheriana.
Fermo nel
proposito di non ritornare mai più in Svizzera, nel 1937 Escher si trasferì con
la famiglia nella città belga di Ukkel (nei pressi di Bruxelles): la seconda
guerra mondiale era alle porte, e l'artista voleva stare anche fisicamente più
vicino ai suoi cari, rimasti nei Paesi Bassi. Nel frattempo la sua arte subì un
drastico cambiamento tematico: Escher iniziò a esplorare le proprie visioni
interiori, non più legato ai moduli paesaggistici degli anni italiani.
La notorietà
di Escher si consolidò, e si moltiplicarono le mostre a lui dedicate e i
riconoscimenti ufficiali. Escher continuò a viaggiare per il Mediterraneo, e
vide i suoi figli «crescere, studiare e
prendere poi la loro strada per il mondo». L'alacre produttività di Escher
si interruppe solo nel 1964, quando, a causa di una grave malattia, dovette
essere operato di urgenza in Canada. Le sue energie creative lentamente si
esaurirono, sino a scomparire del tutto quando nel 1970 si trasferì a Laren,
nell'Olanda settentrionale, nella casa di riposo per artisti. Qui morì il 27
marzo 1972, all’età di quasi settantaquattro anni.
* * *
Durante gli
esordi la produzione artistica di Escher riguardò la paesaggistica. Sono molte,
infatti, le lastre grafiche escheriane che riproducono i tratti dei paesaggi
italiani e delle zone costiere del Mediterraneo: un'attenzione particolare
viene espressamente riservata soprattutto ai borghi montani della Calabria e
della Sicilia, i cui centri abitati si fondono armoniosamente con il paesaggio
circostante (sotto, l’incisione “Pentedattilo Calabro”, del 1930).
* * *
A partire dal 1936
Escher approfondì con maggiore sistematicità le tecniche della tassellatura,
un'operazione per la quale una
superficie viene completamente ricoperta da motivi ripetuti con tutte le
possibili variazioni.
In quell'anno infatti
il grafico visitò per la seconda volta l'Alhambra: la fisionomia architettonica
di questi luoghi era certamente suggestiva e colpì molto Escher. Ad accendere
il suo entusiasmo furono soprattutto le piastrellature moresche, le quali
riproponevano ritmicamente il medesimo motivo ornamentale, orchestrando
composizioni che tecnicamente potevano moltiplicarsi sino all'infinito. «I mori erano maestri proprio nel riempire
completamente superfici con un motivo sempre uguale. In Spagna, all’Alhambra,
hanno decorato pavimenti e pareti mettendo uno vicino all'altro pezzi colorati
di maiolica della stessa forma senza lasciare spazi intermedi» commentava
Escher, traboccante di entusiasmo.
Escher comprese come
le suddivisioni regolari del piano potessero dare vita a esiti grafici
inaspettati e sensazionali. Egli, infatti, capì che per piastrellare una
superficie con un motivo ornamentale quest'ultimo deve essere sottoposto ad
almeno una delle seguenti operazioni: simmetria per traslazione, simmetria per
rotazione, simmetria per riflessione o simmetria per glissoriflessione. In
questo modo Escher riuscì a produrre composizioni come Angeli e diavoli, dove sfruttando abilmente i pieni e i
vuoti vengono fatti corrispondere i rispettivi profili delle due creature,
creando così un motivo replicabile all'infinito.
Escher riteneva che
questo genere non fosse dotato di una dignità artistica autonoma e che pertanto
andasse frequentato in composizioni più ambiziose e di più grande respiro. È il
caso di Giorno e notte (1938), una delle silografie più note dell'artista, dove una
tassellazione bidimensionale raffigurante anatre bianche e nere in volo
degenera in una fantastica visione dall'alto dei campi coltivati olandesi.
Ancora più ambiziosa
e articolata è Metamorfosi II (1939), una silografia dove la
parola «metamorphose» subisce un processo di metamorfosi, trasfigurandosi in
figure geometriche, api, insetti, e persino in una scacchiera e in una veduta
del duomo d'Atrani, per poi ritornare al punto di partenza.
Nei piani tassellati di ” Metamorfosi cì è un’allusione all’
infinito. Ma in altri disegni di Escher appaiono visioni più inquientanti
dell’infinito. In alcuni dei suoi disegni un unico tema potrà ripresentarsi a
diversi livelli di realtà.Per esempio,un livello del disegno rappresenterà
chiaramente la fantasia o l’imaginazione; un altro livello potrà rappresentare
la realtà. Questi due livelli saranno magari gli unici ad essere esplicitamente
raffigurati. Ma la semplice presenza di questi due livelli invita lo spettatore
a considerarsi egli stesso partecipe di un altro livello ancora; e così facendo
egli si troverà irrimediabilmente impigliato nella catena di livelli che Escher
aveva predisposto e in cui , per ognuno dei livelli, c’è sempre un livello più
altro, di maggiore ” realtà”, come pure un livello più basso, ” più
immaginario”. Già di per sè questo fenomeno può essere sconcertante. Ma cosa
succede se la catena dei livelli non è lineare ma forma un anello? Cosa sarà
allora realtà, cosa sarà fantasia? Il genio di Escher sta nella sua capacità di
escogiatare e allo stesso tempo realizzare figurativamente dozzine di mondi semi-reali
e semi-immaginari, mondi piedi di Strani anelli, nei quali sembra invitare i
suoi spettatori ad entrare.
In Ciclo (1938), invece, troviamo un ignaro ragazzotto che corre in uno
scenario architettonico tipicamente amalfitano, per poi trasformarsi
inaspettatamente in una tessera geometrica.
Vale la pena citare
anche Incontro (1944), dove alcune figure bianche e
nere (qualificate da Escher come «ottimiste» e «pessimiste») si distaccano
dalla loro matrice tassellata e prendono vita, per poi avvicinarsi rigidamente
e porgersi amichevolmente la mano.
Rettili
(1943),
invece, è particolarmente interessante in quanto riunisce in maniera
compendiaria ed elegante i vari interessi che hanno animato le ricerche
pittoriche di Escher. Vi sono infatti raffigurati spazi dimensionalmente
diversi che si incontrano, con i piccoli animali preistorici che escono dal
mondo bidimensionale e tassellato di un libro per poi ritornarvi.
* * *
Dopo il 1937, la rappresentazione naturalistica era passata per
Escher in secondo piano. Da quel momento in poi, ciò che lo conquisterà saranno
simmetrie, strutture matematiche, continuità e infinito, e il problema che è
presente in ogni suo quadro: la riproduzione di tre dimensioni su di una
superficie bidimensionale. Tema fondamentale dell'arte escheriana sarà quello
della compenetrazione tra due mondi differenti. Escher spesso si divertì a
esplorare le possibilità della visione e a progettare composizioni che,
nonostante i limiti fisici imposti dalla bidimensionalità del supporto, si
dilatano ed evocano simultaneamente due mondi differenti.
Escher
ripudia la visione monoculare prevista dai tradizionalismi artistici e propone
una rappresentazione più complessa dello spazio, attirando nella dimensione
illusoria dei suoi disegni realtà che tecnicamente dovrebbero essere estranee
al loro spazio figurativo. Si verifica, in un certo senso, il paradosso della diplopia, ove l'autore riunisce due o
tre punti di vista nello stesso disegno, rendendolo così tridimensionale.
L’arte di Escher ruota ormai intorno a un concetto unico e
fondamentale, quello dello spazio, che però non è la semplice
riproduzione su un piano dell'ambiente tridimensionale secondo le leggi della
prospettiva. Il tema indagato da Escher va oltre e si sviluppa sulla base di accorgimenti geometrici che vanno a cercare
le situazioni limite, nelle quali la percezione dello spazio è incerta, ambigua
e gli elementi che lo popolano possono ben essere definiti "oggetti
impossibili".
Per
conquistare quest'inedita spazialità Escher si serve spesso di specchi convessi
e dei loro riflessi. Esemplare, in tal senso, è la litografia Mano con sfera riflettente (1935), dove la realtà ambigua e
illusiva del dipinto viene raddoppiata e oggettivata nella mano che regge la
sfera e nella superficie riflettente di quest'ultima, dove troviamo raffigurato
Escher nel suo studio.
Per operare quest'intrecciò di
più mondi, Escher si servì anche di superfici specchianti piane, come nel caso
di Superficie increspata
(1950), dove la sagoma pallida del sole e i tronchi nudi di alcuni alberi si
riflettono in uno stagno appena velato da leggere increspature ellittiche, che
distorcono la visione e consentono la discriminazione tra l'entità riflettente
(l'acqua disturbata dalle gocce di pioggia) e la realtà riflessa (il paesaggio
circostante).
Risultati ancora più sofisticati
si ottengono in Tre mondi
(1955), dove troviamo illustrate ben tre dimensioni, quella relativa agli
alberi (spogli per via dei rigori dell'autunno), quella relativa alla
superficie d'acqua (individuata dalla miriade di foglie galleggianti) e infine
quella relativa al mondo subacqueo, personificato nel pesce che sguazza in
primo piano.
La poetica della «simultaneità
dei mondi» giunge a esiti ancora più sorprendenti in Specchio magico (1946), dove Escher suggerisce che in realtà
le immagini riflesse potrebbero continuare a vivere di vita propria,
e
in Sole e luna (1948), dove
una tassellatura regolare del piano si congiunge con l'esigenza di
rappresentare il giorno e la notte, con i quattordici uccelli bianchi che
individuano la volta del firmamento notturno, con la luna e gli astri che
brillano nel cielo, e i quattordici volatili neri che con le loro sagome scure
trasportano l'osservatore verso un cielo chiaro striato dai raggi ardenti del
Sole.
Speciale menzione merita la Natura morta e strada (1937),
nella quale «il confine tra davanzale e strada è stato omesso e la struttura
del davanzale si conforma alla strada», in modo tale da congiungere due realtà
chiare e riconoscibili in modo naturale, e neppure del tutto impossibile.
* * *
Escher
con le sue opere si è fatto cantore di un mondo governato da armonie di tipo
geometrico e matematico. «Mi sento spesso
più vicino ai matematici che ai miei colleghi artisti» ammise Escher,
pienamente consapevole di come due mondi apparentemente distantissimi, come
quelli dell'arte e della matematica, riuscissero nei suoi disegni a fondersi in
un'euritmico equilibrio.
Gli anni in cui Escher
approfondiva la propria maturazione artistica, in effetti, erano segnati da un
profondo risveglio di fermenti culturali, decollati grazie allo slancio fornito
dalle scoperte di Heisenberg ed Einstein, dalle esperienze estetiche del
Surrealismo e del Cubismo, dai lavori di Poincarè e Turing. Si andava affermando
una scienza che, se da una parte forniva all'uomo gli strumenti per conoscere
e, dunque, dominare la Natura, dall'altra veicolava anche profonde inquietudini
e insicurezze che, come ebbe modo di asserire lo stesso Escher, aprivano
inesorabilmente pericolosi «sensi di vuoto» nell’esperienza viva dell’uomo.
Lo stesso Escher nella sua arte
faceva ampio ricorso - più o meno consapevolmente - a concetti matematici come le trasformazioni
sul piano cartesiano, masticando anche qualcosa di geometria non euclidea:
molte sue opere arrivano persino a preludere pioneristicamente a principi
scientifici che dovevano risultare assolutamente ignoti all'artista, essendo
germogliati definitivamente solo molti decenni più tardi.
L'arte di Escher tendeva
a cogliere le dimensioni di infinito. Nel 1959 l'artista fornì la seguente
formulazione filosofica del concetto di «infinito»: «L'uomo
è incapace di immaginare che in qualche punto al di là delle stelle più lontane
nel cielo notturno lo spazio possa avere fine, un limite oltre il quale non c'è
che il "nulla". Il concetto di "vuoto" ha per noi un certo
significato, perché possiamo almeno visualizzare uno spazio vuoto, ma il
"nulla" nel senso di "senza spazio" è al di là delle nostre
capacità d'immaginazione. È per questo che da quando l'uomo è venuto a giacere,
sedere, stare in piedi, a strisciare e camminare sulla terra, a navigare,
cavalcare e volare sopra di essa (e lontano da essa), ci siamo aggrappati a
illusioni, a un al di là, a un purgatorio, un cielo e un inferno, a una rinascita
o a un nirvana, che esistono tutti eternamente nel tempo e interminabilmente
nello spazio».
Il nome di Escher è indissolubilmente legato
a quello dei cosiddetti «mondi impossibili». Si tratta di una
formulazione artistica degli stravolgimenti attuati da Albert Einstein con i
suoi due postulati della teoria della relatività, i quali richiedono
l'abbandono della tradizionale concezione dello spazio e del tempo fondata
sull'idea di un continuum spaziale fluente attraverso un continuum
temporale, e conducono all'assunzione di un continuo spazio-temporale in cui
distanze e spazi temporali variano al mutare del sistema di riferimento.
Escher
decide di registrare graficamente la paradossalità delle conquiste concettuali
einsteiniane in opere come Relatività
(1953).
Si tratta di una litografia che raffigura un universo relativistico spaesante, surreale, dove la percezione dei vari ambienti è affidata al punto di vista scelto dall'osservatore. Nello spazio illusivo della litografia sono infatti compresse tre dimensioni spaziali tra loro ortogonali: le varie entità ivi effigiate, pertanto, possono essere interpretate in modi diversi a seconda della dimensione considerata (si può facilmente osservare, ad esempio, come ciò che in un mondo è una parete, in un altro è un soffitto, o magari un pavimento).
L'identificazione
delle figure di Relatività, pertanto, cessa di essere un'operazione meccanica
ed esige l'adozione di un punto di vista, giocoforza relativo, da parte
dell'osservatore: ecco, allora, che ogni cosa appare del tutto normale se
considerata localmente, ma è alquanto strana e surreale se considerata in
rapporto al resto. Questa relativizzazione dello spazio pittorico culmina poi
nelle scale, le cui alzate e pedate sono perfettamente interscambiabili.
Sono moltissime, tuttavia, le rappresentazioni escheriane che, a dispetto della
loro unitarietà, colgono simultaneamente più mondi distinti, sfidando la
concettualità che da secoli si era sedimentata nella psiche umana.
Un'ambiguità
di visione analoga la si riscontra anche in Salita e discesa (1960), raffigurante un complesso edilizio
sulla cui sommità troviamo alcuni monaci che si susseguono in una scalinata
sempre in salita, o sempre in discesa. L'elusività dell'opera è lampante:
seguendo il percorso dei monaci, infatti, si riscontrerà come dopo un ciclo di
«salita» o «discesa» quest'ultimi si ritrovino allo stesso punto di partenza.
In Cascata (1961), invece, vi è un
flusso d'acqua che sembra localmente in piano, ma globalmente in salita.
L'acqua contenuta nel canale, infatti, dopo aver zigzagato seguendo i profili
di due triangoli immaginari precipita in una cascata scrosciante che alimenta
un mulino il quale, a sua volta, spinge nuovamente l'acqua in un canale: si
viene così a creare un moto perpetuo all'interno di un sistema chiuso, in
aperta controtendenza con quanto prescritto dalla legge di conservazione
dell'energia.
In Belvedere (1958) lo spazio
architettonico è orchestrato in modo tale da generare nell'osservatore un vero
e proprio shock visivo. Per la spazialità di quest'ultima opera, Escher riesce
a intrecciare opportunamente le colonne diagonali sulle quali si struttura
l'intero palazzo ivi raffigurato.
*
* *
La ricerca
dell’ultimo Escher si rivolge verso un approdo concettuale ai confini tra i
nuovi orizzonti della fisica e della filosofia esistenziale.
“Ho notato
che alcune persone a volte pensano che fare domande come: «Che cos’è la
realtà?» sia inutile e che non abbia a che fare con le realtà quotidiane.
Ma supponiamo per un momento che il nostro mondo “là fuori” sia costruito dalla
nostra percezione. Dovremmo prendere in esame la relazione tra
la nostra coscienza e la realtà materiale… e che
possa essere addirittura la coscienza stessa ad
essere la sostanza fondamentale dell’universo”.
Già nel
XVIII secolo, il filosofo tedesco Immanuel Kant aveva sostenuto che gli esseri
umani non possono mai conoscere
davvero la natura della realtà così com’è. Le nostre indagini
forniscono soltanto risposte agli interrogativi che poniamo, i quali sono
basati sulle capacità e limitazioni
della nostra mente. Tutto quello che percepiamo nel mondo
naturale, sia attraverso i nostri sensi che attraverso la scienza, passa
attraverso il filtro della nostra coscienza, ed è determinato, perlomeno fino a
un certo punto, dalle strutture proprie della mente. Così, quelli che vediamo
sono “fenomeni”, ovvero
l’interazione tra la mente e qualsiasi cosa ci sia “realmente là fuori”.
Noi, dunque,
non vediamo la realtà; vediamo soltanto la nostra costruzione della realtà,
fabbricata dai neuroni del nostro cervello. In altre
parole, la scienza ci fornisce soltanto dei modelli del mondo, non il mondo
stesso.
Come afferma
Miceal Ledwith, « … la visione
quantistica della realtà non è la risposta risolutiva. Nella storia della
scienza non stiamo cercando di fare altro che produrre modelli sempre meno
imperfetti per esprimere la natura di
ciò che esiste e,
naturalmente, forse tra venti o trent’anni la fisica quantistica sarà sostituita da una comprensione più
profonda e radicale della realtà, qualunque sia il nome che verrà dato a
quella fisica».
Maurits Cornelis Escher, autoritratto - 1929
__________________________________________________
Il I 'Salottino'
del 9 e del 16 ottobre 2018
Preghiera in gennaio
Lascia che sia fiorito Signore il suo sentiero
quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle
dovrà riconsegnare quando verrà al tuo cielo
là dove in pieno giorno risplendono le stelle.
quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle
dovrà riconsegnare quando verrà al tuo cielo
là dove in pieno giorno risplendono le stelle.
Quando attraverserà l’ultimo vecchio ponte
ai suicidi dirà baciandoli alla fronte
venite in Paradiso là dove vado anch’io
perchè non c’è l’inferno nel mondo del buon Dio.
ai suicidi dirà baciandoli alla fronte
venite in Paradiso là dove vado anch’io
perchè non c’è l’inferno nel mondo del buon Dio.
Fate che giunga a voi con le sue ossa stanche
seguito da migliaia di quelle facce bianche
fate che a Voi ritorni fra i morti per oltraggio
che al cielo ed alla terra mostrarono il coraggio.
seguito da migliaia di quelle facce bianche
fate che a Voi ritorni fra i morti per oltraggio
che al cielo ed alla terra mostrarono il coraggio.
Signori benpensanti spero non vi dispiaccia
se in cielo in mezzo ai Santi Dio fra le sue braccia
soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte
che all’odio e all’ignoranza preferirono la morte.
se in cielo in mezzo ai Santi Dio fra le sue braccia
soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte
che all’odio e all’ignoranza preferirono la morte.
Dio di misericordia il tuo bel Paradiso
lo hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso
per quelli che han vissuto con la coscienza pura
l’inferno esiste solo per chi ne ha paura.
lo hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso
per quelli che han vissuto con la coscienza pura
l’inferno esiste solo per chi ne ha paura.
Meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare
gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare.
Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento
Dio di misericordia vedrai, sarai contento.
gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare.
Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento
Dio di misericordia vedrai, sarai contento.
Dio di misericordia vedrai, sarai contento.
(Compositori:
Fabrizio De Andre / Gian Piero Reverberi)
De André
dichiarò di aver scritto questa canzone al ritorno dal funerale di Luigi Tenco
amico cantautore di De André morto suicida a 29 anni, nel gennaio 1967.
"L'ho dedicata a Tenco. Scritta, o meglio
pensata nel ritorno da Sanremo dove c'eravamo precipitati io, la mia ex moglie
Enrica Rignon e la Anna Paoli. Dopo aver visto Luigi disteso in quell'obitorio
(fuori Sanremo peraltro, perché non ce l'avevano voluto) tornando poi a Genova
in attesa del funerale che si sarebbe svolto due giorni dopo a Cassine, mi pare,
m'era venuta questa composizione. Sai, ad un certo punto non sai cosa fare per
una persona che è morta, ti sembra quindi quasi di gratificarla andando al suo
funerale, scrivendo - se sei capace di scrivere e se ne hai l'idea - qualcosa
che lo gratifichi, che lo ricordi... forse è una forma... ma d'altra parte è
umano, credo... non l'ho di certo scritta apposta perché la gente pensasse che
io avevo scritto apposta una canzone per Luigi, tant'è vero che non c'era
scritto assolutamente da nessuna parte che l'avevo composta per lui”.
"Preghiera in
gennaio" fu incisa nell'album "Volume 1" del 1967.
Il testo è ispirato alla poesia "Prière pour aller au paradis avec le anes"
(Preghiera per andare in paradiso con gli asini) composta nei primi del '900 dal poeta francese Francis Jammes.
Lorsqu’il
faudra aller vers vous, ô mon Dieu, faites
que ce soit par un jour où la campagne en fête
poudroiera. Je désire, ainsi que je fis ici-bas,
choisir un chemin pour aller, comme il me plaira,
au Paradis, où sont en plein jour les étoiles.
que ce soit par un jour où la campagne en fête
poudroiera. Je désire, ainsi que je fis ici-bas,
choisir un chemin pour aller, comme il me plaira,
au Paradis, où sont en plein jour les étoiles.
Je prendrai
mon bâton et sur la grande route
j’irai, et je dirai aux ânes, mes amis:
Je suis Francis Jammes et je vais au Paradis,
car il n’y a pas d’enfer au pays du Bon-Dieu.
Je leur dirai: Venez, doux amis du ciel bleu,
pauvres bêtes chéries qui, d’un brusque mouvement d’oreilles
chassez les mouches plates, les coups et les abeilles…
j’irai, et je dirai aux ânes, mes amis:
Je suis Francis Jammes et je vais au Paradis,
car il n’y a pas d’enfer au pays du Bon-Dieu.
Je leur dirai: Venez, doux amis du ciel bleu,
pauvres bêtes chéries qui, d’un brusque mouvement d’oreilles
chassez les mouches plates, les coups et les abeilles…
Que je vous
apparaisse au milieu de ces bêtes
que j’aime tant parce qu’elles baissent la tête
doucement, et s’arrêtent en joignant leurs petits pieds
d’une façon bien douce et qui vous fait pitié.
que j’aime tant parce qu’elles baissent la tête
doucement, et s’arrêtent en joignant leurs petits pieds
d’une façon bien douce et qui vous fait pitié.
J’arriverai
suivi de leurs milliers d’oreilles,
suivi de ceux qui portèrent aux flancs des corbeilles,
de ceux traînant des voitures de saltimbanques
ou des voitures de plumeaux et de fer blanc,
de ceux qui ont au dos des bidons bossuées,
des ânesses pleines comme des outres, aux pas cassés,
de ceux à qui l’on met de petits pantalons
à cause des plaies bleues et suintantes que font
les mouches entêtées qui s’y groupent en ronds.
suivi de ceux qui portèrent aux flancs des corbeilles,
de ceux traînant des voitures de saltimbanques
ou des voitures de plumeaux et de fer blanc,
de ceux qui ont au dos des bidons bossuées,
des ânesses pleines comme des outres, aux pas cassés,
de ceux à qui l’on met de petits pantalons
à cause des plaies bleues et suintantes que font
les mouches entêtées qui s’y groupent en ronds.
Mon Dieu,
faites qu’avec ces ânes je vous vienne.
Faites que, dans la paix, des anges nous conduisent
vers des ruisseaux touffus où tremblent des cerises
lisses comme la chair qui rit des jeunes filles,
et faites que, penché dans ce séjour des âmes,
sur vos divines eaux, je sois pareil aux ânes
qui mireront leur humble et douce pauvreté
à la limpidité de l’amour éternel.
Faites que, dans la paix, des anges nous conduisent
vers des ruisseaux touffus où tremblent des cerises
lisses comme la chair qui rit des jeunes filles,
et faites que, penché dans ce séjour des âmes,
sur vos divines eaux, je sois pareil aux ânes
qui mireront leur humble et douce pauvreté
à la limpidité de l’amour éternel.
* * *
Traduzione italiana di Gianni Montagna:
Preghiera per andare in Paradiso con gli
asini
Quando dovrò
venire verso di te, Signore,
fa che un bel giorno sia, che la campagna in fiore
risplenda. Il mio sentiero vorrei, come quaggiù,
scegliermi per andare, come mi piacerà,
al Paradiso, dove di giorno son le stelle.
fa che un bel giorno sia, che la campagna in fiore
risplenda. Il mio sentiero vorrei, come quaggiù,
scegliermi per andare, come mi piacerà,
al Paradiso, dove di giorno son le stelle.
Prenderò il mio
bastone e sulla strada grande
andrò, dicendo ai miei amici, gli asinelli:
Io sono Francis Jammes e vado in Paradiso,
ché non c’è inferno nel paese del buon Dio.
E dirò lor: Venite, del cielo azzurro, amici,
povere bestie che con un muover d’orecchi
discacciate le api, le busse ed i tafani…
andrò, dicendo ai miei amici, gli asinelli:
Io sono Francis Jammes e vado in Paradiso,
ché non c’è inferno nel paese del buon Dio.
E dirò lor: Venite, del cielo azzurro, amici,
povere bestie che con un muover d’orecchi
discacciate le api, le busse ed i tafani…
Che io ti
apparisca in mezzo a queste bestie,
che per questo mi piacciono: che abbassano la testa
dolcemente e si fermano giungendo i lor piedini
in un modo dolcissimo e che ti fa pietà.
che per questo mi piacciono: che abbassano la testa
dolcemente e si fermano giungendo i lor piedini
in un modo dolcissimo e che ti fa pietà.
Arriverò
seguito da migliaia d’orecchi,
da quelli che portarono pesanti ceste ai fianchi,
da quei che trascinarono carri di saltimbanchi,
o carretti ricolmi di pentole e piumini,
da quelli che han sul dorso dei bidoni ammaccati,
dalle asine pregne, come otri i fianchi enfiati,
da quelli ai quali infilano come dei calzoncini,
per le bluastre piaghe che fanno purulente
le mosche che testarde vi s’attaccano intorno.
da quelli che portarono pesanti ceste ai fianchi,
da quei che trascinarono carri di saltimbanchi,
o carretti ricolmi di pentole e piumini,
da quelli che han sul dorso dei bidoni ammaccati,
dalle asine pregne, come otri i fianchi enfiati,
da quelli ai quali infilano come dei calzoncini,
per le bluastre piaghe che fanno purulente
le mosche che testarde vi s’attaccano intorno.
Signore, con
questi asini a te venga, quel giorno.
E fa che siano gli angeli a guidarci alla pace,
verso ruscelli erbosi che specchiano ciliegie
lisce come una carne ridente di fanciulle;
che curvo sulle tue acque divine, in quella
dimora degli eletti, agli asini somigli,
la povertà miranti, umile e dolce loro,
dentro la limpidezza di un eterno amore.
E fa che siano gli angeli a guidarci alla pace,
verso ruscelli erbosi che specchiano ciliegie
lisce come una carne ridente di fanciulle;
che curvo sulle tue acque divine, in quella
dimora degli eletti, agli asini somigli,
la povertà miranti, umile e dolce loro,
dentro la limpidezza di un eterno amore.
Nella Preghiera in gennaio
non compare il nome del protagonista nel titolo, e neanche nel testo, forse
perché non era necessario. Infatti è noto che la canzone fosse dedicata
all’amico Luigi Tenco, morto suicida nella sua camera d’albergo dopo
l’esclusione della sua canzone (“Ciao
amore ciao”) nel festival di
Sanremo. La stampa speculò molto su questo fatto tragico e la Rai censurò la
trasmissione di questo componimento musicale, che andò in onda per la prima
volta sulla Radio Vaticana. Forse la Rai aveva paura, come disse lo stesso
cantautore, che fosse “un’esaltazione del suicidio”.
Luigi Tenco
(Cassine, Alessandria 21 marzo 1938 – Sanremo, 27 gennaio 1967)
Preghiera in gennaio non racconta una storia, ma si
connota come una vera e propria preghiera rivolta a Dio per quelli che al cielo ed alla terra mostrarono il
coraggio. Tenco aveva lasciato scritto: “Faccio
questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come atto di
protesta”. De Andrè usa infatti le parole oltraggio, odio, ignoranza (rivolte
al pubblico dell’epoca), che contrastano con la coscienza pura
di chi ha vissuto pienamente e tuttavia decide di morire. La misericordia,
ancora una volta, e come lo sarà in decine di canzoni lungo tutta la sua
carriera, è un sentimento profondamente umano che va al
di là di ogni etichetta – ateo, laico o cristiano che sia.
* * *
La musica fu composta da De André con
la collaborazione di Giampiero Reverberi. De
André stimava molto Tenco dal punto di vista artistico essendo uno di quei
cantautori che trattava, nei suoi testi, tematiche molto vicine al proprio
stile oltre ad avere un'idea politica molto simile. Non molto tempo prima della
scomparsa di Tenco, tra l'altro, i due avevano parlato di una possibile futura
collaborazione artistica che ipotizzavano da tempo.
Quella partecipazione a Sanremo che
Tenco, come De André, aveva sempre rifiutato divenne per l'artista una gabbia
mortale. Subito dopo appresa la notizia, nella notte tra il 26 e 27 gennaio, De
André si precipita a Sanremo con Puny, nomignolo
dell'ex moglie Enrica Rignon, e con Anna Paoli e, osservando il
corpo di Luigi nell'obitorio, venne colpito dal pallore della morte e dal
colore scuro delle sue labbra carnose. Sulla strada di ritorno per Genova, in
attesa dei funerali che si sarebbero tenuti due giorni dopo, De André ebbe
l'ispirazione da cui nacque questa composizione.
De André immagina, nel testo, il
trattamento che andrebbe riservato nell'aldilà a un suicida che ha preferito la
morte all'odio e all'ignoranza
presenti nella vita terrena. Elogia, quindi, il coraggio di un uomo che ha
scelto di non vivere in un mondo che non gli apparteneva. De Andrè, quindi, si
auspica che il buon Dio possa accoglierlo tra le sue braccia rincuorandolo ed
aiutandolo a soffocare il singhiozzo di
quelle labbra smorte in barba ai benpensanti che lo vorrebbero tra le
fiamme dell'inferno. L'inferno, per De André, dovrebbe esistere solo per chi,
non avendo una coscenza pura, e non hanno neppure il coraggio di credere nella
misericordia divina. Il paradiso, invece, è destinato a chi, nella vita, non ha
potuto sorridere.
Nell'ultimo verso, De André invita
Dio ad ascoltare la voce di Luigi, che
ormai canta nel vento, prestando l’orecchio ad un'anima candida, stritolata
dall’odio e dall’ignoranza.
Preghiera in gennaio
(per chitarra sola)
* * *
Preghiera in gennaio non è una canzone che parla per ellissi e
allusioni, quello che deve venire detto è detto, le parole morte e suicidio
compaiono. Quindi grande coraggio (fu scritta 45 anni fa), e grande
provocazione, nel dipingere un Dio pietoso verso i peggiori peccatori.
“Dio di misericordia, vedrai sarai contento”: quanto amore in sei parole: il saluto di un
amico ad un amico, senza rancore, e questa idea favolosa che il suicida,
come è stato un dono in vita per chi l’ha conosciuto, così lo sarà in morte
addirittura per Dio.
De Andrè ha
veramente compreso ogni cosa: la misericordia di Dio supera qualunque
gesto umano; se l’uomo può decidere anche di compiere questo atto di estrema
protesta, quante mani invisibili avranno armato ”quella”mano e quante mani
invisibili avranno contribuito a dare “quella” spinta fatale? Ogni suicidio è
un fallimento per l’intera razza umana. Ecco perché la misericordia di Dio per
le sue creature sovrasta ogni cosa, perché - come diceva S. Paolo - ”dove
abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia”. Esistono forse dei percorsi
insondabili per queste anime, ma alla fine il ricongiugimento con Dio, che è
amore allo stato puro, dovrà avvenire.
* * *
La mattina
dell’11 gennaio 1999 moriva Fabrizio De André. Dal suo primo album, "Volume I", all’ultimo, "Anime salve", passano 28 anni, 15
album e 128 canzoni.
La prima
porta il titolo di Preghiera in gennaio,
l’ultima, Smisurata preghiera. La vita
artistica del cantautore è racchiusa tra due preghiere, di cui la seconda è in
crescendo, smisurata. Solo una suggestiva
casualità o qualcosa di più? La prospettiva religiosa, nell’arte del cantautore
genovese, è una pista da battere a fondo; il rischio è quello di scorgervi
perle di rara bellezza (e veder cadere molti luoghi comuni).
Per De
André le etichette si sono sprecate: ateo, agnostico, animista, anarchico.
Basterà però ricordare quello che De André disse e cantò: servirà per aprire
gli occhi sull’appassionata ricerca del vero che ha accompagnato la vita del
grande poeta. «C’è chi è toccato dalla
fede – scriveva De André - e chi si limita a toccare la virtù della speranza
(…), il Dio in cui, nonostante tutto, continuo a sperare, è un’entità al di
sopra delle parti, delle fazioni». È proprio la categoria della Speranza,
da lui stesso definita virtù, quella che meglio esprime il profilo religioso
del cantautore.
Ettore
Cannas, nel suo bel libro “La dimensione
religiosa nelle canzoni di Fabrizio De André” (ed. Segno), con un’accurata
indagine statistica, ha catalogato i termini contenuti nei testi di De André. I
risultati sono interessanti. Si scopre che i quattro termini più utilizzati dal
cantautore nell’intera sua produzione sono: "Dio/Signore",
"Amore", "Cielo" e "Vento"; questi ultimi
utilizzati sovente in senso metafisico (vento è spesso usato nel significato
biblico di ruah, il soffio dello Spirito). La
terminologia politica, poi, è quasi del tutto assente (Cannas fa notare che
mancano del tutto termini quali "borghesia", "ribellione",
"anarchia", "dittatura", "fascista," "marxista",
"operaio", "politica", "proletario").
Dal punto
di vista stilistico, particolarmente interessante è l’uso, nel testo di “Preghiera
in gennaio”, di chiasmi speculari in forma di elementi lessicali (parole con
significati contrapposti: anima-pelle, paradiso-inferno, cielo-terra, singhiozzo-sorriso…)
e di assonanze vocaliche ricorrenti (-ia/-ai, -oi/-io, -oe/-eo…), suggestivi contrasti
di immagini e di sonorità che richiamano efficacemente le contraddizioni
esistenziali evocate nel canto.
* * *
Il testo
della canzone rivela la profonda umanità di Fabrizio De André che, pur essendosi
sempre dichiarato ateo, nelle sue canzoni incarna la carità, l’umiltà e la
speranza di ogni confessione e fede religiosa.
La cosa che
colpisce di più è la semplicità delle parole con le quali De André assegna e
giustifica il posto “riservato” a Tenco in paradiso. Un particolare
interessante sta nel fatto che il testo da anni è stato, tra l’altro, incluso
in numerose antologie scolastiche di letteratura italiana.
La morte di
Tenco assume connotati ancora più tristi se si pensa al suo funerale non si
presentò nessun celebre collega cantante. Tenco fu lasciato solo con il suo
dolore, sia prima che dopo la sua morte. E allora ancora oggi, assume un
significato maggiore il ricordo di coloro che, come De André, non fecero finta
di niente laddove fare finta di niente era più facile che abbandonare al suo
destino un uomo, un cantante, “un compositore”.
È forse
questo il finale più tragico e impietoso che cala il sipario su di una vita
indimenticata e indimenticabile. Il giorno dopo i funerali di Tenco, così si
leggeva su “La Stampa” del 31 gennaio 1967: “I cantanti che la notte del suicidio avevano pianto, urlato e imprecato,
sono rimasti a dormire: non hanno inviato neppure un fiore – Il mesto corteo è
stato seguito da una folla di anonimi ammiratori”.
* * *
Nel ricordo di
Fabrizio De André:
“Luigi,
come me, era contrarissimo ai festival e poi ci si è trovato stritolato dentro.
Lui era un uomo di sinistra, della sinistra di allora. Credo, comunque, che il
suo gesto sia maturato anche in conseguenza delle sue letture. Luigi sul
comodino teneva i libri di Pavese; ne ho conosciuti altri che si sono suicidati
dopo aver letto troppe volte Pavese.
Io
lo frequentavo abbastanza saltuariamente, eravamo tutti cani sciolti, ma
sicuramente era quello che mi era più vicino come formazione politica e poi, da
artista, come tematiche trattate. Appena saputa la notizia della sua morte, mi
precipitai all'obitorio. Quando lo vidi lì disteso, con questo turbante di
garza insanguinato, mi colpirono il pallore della morte e il colore viola scuro
delle sue labbra carnose. Le ho ancora impresse nella mente, e le menzionai
nella canzone che scrissi sull'onda di quell'emozione partendo da una poesia di
un autore del novecento francese, Francis Jammes”
Fabrizio De André
(
- Elaborazione fotografica di A. Montanaro -
* * *